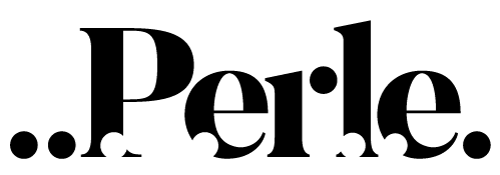Rachele Borghi. Pensare decolonialmente
Un estratto dal volume di Rachele Borghi Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema-mondo, casa editrice Meltemi 2023, collana Culture Radicali. L’estratto è comparso su Opera Viva Magazine.
[Immagine di copertina: Abdulmonam Eassa, Nanterre France, June 2023]
Rachele Borghi, Pensare decolonialmente. L’entrata in uso negli anni Ottanta del termine postcolonialismo non ha contribuito a fare chiarezza. Il prefisso post, nonostante non avesse un valore temporale ma andasse piuttosto ad indicare il superamento di un punto di vista sul mondo e di un cambiamento di paradigma 1, ha, di fatto, radicato l’idea che il mondo fosse uscito dal colonialismo e entrato in un periodo che si lasciava alle spalle la colonizzazione dei territori. Insomma, ci siamo tutti illuse che il colonialismo fosse finito e che ora si partisse da zero dato che, per legge, tuttie siamo uguali, liberie e cittadinie di uno Stato-nazione. Il migliore dei mondi possibili.
Questa visione non solo ci ha fatto vivere nell’illusione ma ha anche portato con sé confusione. Quando si parla di colonialismo si fa riferimento ad un processo (storico), quello di espansione, di conquista di un territorio e di sovranità di un paese su un altro. La decolonizzazione, quindi, diventa il processo (storico) di uscita dal colonialismo per arrivare all’indipendenza. Decolonizzare è il suo verbo. Mi pare però che anche qui ci sia un problema. Nella sua forma transitiva, secondo me nasconde sempre un posizionamento specifico, quello di chi domina (“Decolonizzare un paese da un altro”). Per dislocare il centro verso chi è dominato e sottolineare la conquista dell’autodeterminazione, bisogna volgerlo alla forma riflessiva, “decolonizzarsi”. Da qui per me partono due considerazioni: la prima è che il verbo nella sua forma transitiva è corrotto, dato che rimanda ad un soggetto agente che concede la libertà (“decolonizzare qualcosa da qualcuno”); in secondo luogo la decolonizzazione può solo essere un processo che parte dal soggetto che agisce, ovvero che si decolonizza.
Un’altra grammatica è necessaria per capire dove siamo ora, visualizzare la situazione nel sistema-mondo e immaginare scenari diversi a cui tendere. Questa grammatica c’è e si chiama teoria/pensiero/critica/approccio/proposta decoloniale. Il pensiero decoloniale non fa riferimento alla decolonizzazione dal colonialismo: fa riferimento alla colonialità. E non riguarda un periodo passato ma ha la forma del presente.
Recentemente mi è stata diagnosticata la fibromialgia. Pare che per ridurre i dolori sia necessario che cambi alimentazione. L’alimentazione è un fattore determinante per creare un ambiente acido o basico nel corpo. Il mio corpo è acido. È diventato acido a causa degli elementi che ho introdotto attraverso il cibo, quelli nello stile di vita (sedentarietà), quelli presenti nell’ambiente (pesticidi, inquinamento) e quelli di sistema (ingiustizia, precarietà, conflitti, troppo carico di lavoro, carico emotivo). Non lo sapevo di avere un ambiente acido. Vivo però la quotidianità immersa nell’acidità del mio corpo: l’acidità è strutturale al mio corpo, è incorporata, il malessere interiorizzato, i dolori ineluttabili. Per uscire da questa situazione è necessario un processo di coscientizzazione che mi porti a fare attenzione non solo a cosa mangio e alla spesa che faccio. Per cambiare l’ambiente del mio corpo è necessario un cambiamento radicale: riformattare completamente la mia maniera di pensare il cibo e il mio stile di vita. Questo significa ripensare la mia quotidianità, come mi relaziono agli altri, come sto nel mondo.
L’acidità del nostro corpo collettivo si chiama colonialità. Colonialismo e modernità sono i due fattori che, interagendo l’uno con l’altro, hanno dato vita all’ambiente acido in cui si è sviluppato il corpo collettivo, il sistema-mondo. La violenza è stata, tra gli elementi introdotti, quello a più alto potenziale acidificante. La decolonizzazione, cominciata nella seconda metà del XX secolo, ha permesso di eliminare un fattore di forte acidificazione (controllo politico ed economico di un paese su un altro). Decolonizzare ha significato avviare il processo di eliminazione dell’elemento colonizzazione per uscire dal colonialismo Politico. Ma questo è solo un fattore. Per eliminare la colonialità ci vuole un’interazione di più fattori e per arrivare ad un ambiente decoloniale (basico) ci vuole una bonifica completa del corpo: un processo di decolonialità. Bisogna cioè capire come decolonializzare, ovvero uscire dalla colonialità, perché decolonizzare non è bastato e non basta.
Alcuni paesi come Puerto Rico o la Palestina continuano ad essere sotto forme di colonialismo; nonostante ciò continuiamo a dire che la decolonizzazione è finita. Pensare i rapporti di dominazione, lo sfruttamento, l’ingiustizia su scala mondiale come forma di colonialismo ci sembra improprio. Nessun dubbio poi che tu che stai leggendo, come me e come tutte le altre persone che immagino prenderanno in mano questo libro, si definiscano anti-coloniali. Detto questo, nessuno di noi è, ne sono altrettanto certa, esonerata dalle plurime forme di colonialità. Credo che sia necessario sgomberare la mente individuale e quella collettiva da ogni dubbio: il problema oggi è la colonialità, non solo il colonialismo. I territori, quelli della mente, quelli dell’essere, quelli del potere vanno quindi decolonializzati, liberati cioè dalla colonialità. Decolonizzare e decolonializzare. I due termini sono simili. La loro genealogia, il loro uso, le immagini a cui fanno riferimento invece no. Ma soprattutto, il primo verbo ti permette di farti qualche sconto, il secondo no. L’idea che mi sono fatta è che il verbo decolonizzare, usato oggi come termine per rigettare i rapporti di dominazione, di sottomissione e di dipendenza radicati col sistema coloniale, rimandi direttamente ad una postura anti-coloniale.
Tuttoggiusto. Però non basta. L’anti-colonialismo, infatti, ha nascosto e rischia ancora di farlo, una postura eurocentrica. E questo diventa ancora più pericoloso nel momento in cui esonera dal mantenere lo sguardo sull’oppressore che è in ognuna di noi. Perché purtroppo non basta avere una coscienza politica, fare parte di una categoria discriminata. Svestire i panni dell’oppressora e vestire quelli dell’alleata, necessita un’attenzione costante, senza abbassare mai la guardia o ritenersi al riparo dal rischio di adottare una postura coloniale. Se possiamo dirci tuttie decolonizzati dall’ideologia coloniale, il lavoro per decolonializzarci, levarci di dosso la colonialità, è ancora tutto da fare. E va fatto a scale, passando dalla dimensione individuale a quella collettiva, con andate e ritorni. Perché tutti gli ambienti sono intrisi di colonialità. I corpi che li attraversano se ne imbevono e ne diventano portatori inconsapevoli. Per questo credo sia necessario incrementare l’impiego di un altro termine, decolonializzare, che, sebbene raro, è già in uso sia in italiano che in francese. In questo modo, sarà chiaro di che progetto parliamo. Io credo che ogni concetto pronunciato, ogni parola apra dei file in ognuno di noi. A volte i file sono stati creati da tempo e vanno bene così, altri vanno aggiornati, altri vanno creati. Credo che il file della colonialità e quello della decolonialità che ne consegue, non siano ancora operativi in molti e di noi. C’è di sicuro il file colonialismo, anti-colonialismo, decolonizzazione. Ma se non gli cambiamo nome, il rischio è quello di aggiornare un file creato a partire da metadati (epistème) che rischiano di comprometterlo. Perché accettare la proposta decoloniale significa essere prontie a riformattare il sistema e a mettere i file attuali nella cartella old.
Decolonializzare ha anche il vantaggio di poter rimandare ad una dimensione micro, quella di te, del tuo corpo, del tuo spazio, del tuo contesto. Permette di indicare non solo la volontà di uscire dal colonialismo ma anche l’azione costante di cercare, sperimentare, portare avanti pratiche, esercizi per uscire dalla colonialità e raggiungere la decolonialità. Perché la decolonialità è oggi ancora un obiettivo da raggiungere, un territorio da costruire. Decolonializzare significa, allora, con dividere pratiche di decolonialità e crearne collettivamente i territori. Si tratta di un progetto collettivo ma non è unico: è un progetto plurimo, di pluriversità. Bisogna creare le condizioni perché punti di vista diversi possano partire da punti del mondo diversi, perché si possano moltiplicare i luoghi di enunciazione. Guardare e stare nel mondo pluriversalmente è già un passo nella costruzione della decolonialità, un territorio che non è omogeneo, e non può essere compreso all’interno di confini delineati. Immaginarlo così sarebbe, di nuovo, fare prova di colonialità, nel momento in cui questo rimanda ad una concezione moderno-cartesian-razionale. Questa ricerca implica lo sforzo di decolonializzare la maniera di pensare, di uscire dagli schemi di pensiero creati dalla colonialità (e che di conseguenza io, te e probabilmente tutte le persone che leggono questo libro abbiamo interiorizzato e con cui abbiamo imparato a guardare la realtà).
Ricorda Grosfoguel (2016):
Se il pensiero decoloniale è diverso, se con esso definiamo insieme cos’è la realtà, la verità o quello che è meglio per tutte le persone, allora l’universale di cui parliamo è già pluriversale. Troviamo questo pluriversalismo in Aimé Césaire, negli Zapatisti e anche in molte proposte di pensatori e critici all’interno dei popoli colonizzati. Non possiamo cadere nel tranello di rendere una di queste proposte decoloniali la sola possibile, la proposta universale 2.
Pensare decolonialmente un mondo pluriversale significa immaginarlo come un arcipelago di punti di enunciazione, una costellazione di micropolitiche di decolonialità, di laboratori di sperimentazione, a partire dal proprio posizionamento e dai propri privilegi.
Decolonializzare significa pensare che la realtà possa essere caleidoscopica: assomigliare più alle immagini del caleidoscopio che alle proiezioni cartografiche. Il caleidoscopio permette di vedere le cose diversamente e di costruire immagini nuove di realtà nuove. Non è solo una questione di punti di vista, è piuttosto una questione di punti di azione. È uno strumento che restituisce immagini plurime, senza centri e periferie. Basta poi farlo roteare, far muovere i vetrini colorati contenuti al suo interno perché l’immagine si trasformi, perché appaiano nuove costellazioni colorate. Il caleidoscopio ci permette di vedere la pluriversità del sistema-mondo. Accettare la proposta decoloniale significa non solo cambiare le lenti con cui guardiamo la realtà ma cambiare radicalmente gli strumenti con cui guardiamo/interpretiamo/ci proiettiamo in essa.
Il caleidoscopio decoloniale si può costruire? Nelle pagine che seguiranno vorrei proporre una breve guida in cui troverai:
Descrizione dell’atelier di montaggio del caleidoscopio, ovvero lo spazio in cui ci troviamo. Credo sia importante delineare i contorni del contesto. In questo caso lo spazio in cui il sapere viene fabbricato e da chi. Parlerò dell’università come istituzione produttrice di violenza epistemica e di sapere posizionato e di come molto pensiero critico non abbia avuto il coraggio di accettare la proposta decoloniale e di combattere fino in fondo i rapporti di dominazione intrinseci alla produzione di sapere scientifico occidentale. Ho scelto questo contesto perché è il mio, quindi quello che conosco meglio. Ma la questione del rapporto tra potere e sapere e della violenza istituzionale riguarda tutti i contesti, dato che è strutturale al sistema in cui viviamo.
Manuale di istruzioni. Qui viene presentata la proposta decoloniale che, svincolandosi dal binomio teoria/pratica, èriuscita a produrre delle prassi. Nella teoria decoloniale ci sono quindi già presenti le istruzioni.
Kit di montaggio. È composto dagli elementi che abbiamo a disposizione. Parti diverse, elementi da assemblare e da risignificare per trasformare i rapporti di dominazione in alleanze e complicità, a partire da quello che c’è. Perché quello che c’è non deve essere per forza usato così com’è ma si può anche ribaltarlo, scomporlo e ricomporlo in un assemblaggio irriverente e anti-oppressivo. Scrivere questo testo, ovvero assemblare per iscritto idee, teorie, pratiche, azioni, riflessioni è un tentativo di dare un contributo individuale all’accettazione collettiva della proposta decoloniale. Non so se ce la faccio. Ci provo (e mi appello a sbaglieranza) 3.
Cominciamo.
Note:
1 Quando si incontra la parola paradigma in un saggio, nella maggior parte dei casi si sta parlando di scienza. Si parla di paradigma per indicare un modo di guardare il mondo, di leggere la realtà condiviso da una comunità scientifica. Si parla di paradigma di riferimento per indicare il fatto che sia appunto condiviso in un certo tempo, in una certa epoca, per un certo periodo e da alcune persone. Il paradigma di riferimento diventa paradigma dominante quando le persone scienziate che l’hanno costruito o che vi aderiscono hanno più potere, più spazi di diffusione, più legittimità di altre. La forza di un paradigma è spesso data dal fatto che la maniera di pensare e di vedere le cose che lo forma non viene esplicitata. Il paradigma è tanto più forte quanto più è interiorizzato e quindi più al riparo dal rischio di essere messo in discussione. Ad esempio, la mia università ha una tradizione di geografia empirista e positivista. Questo è il paradigma dominante. Non ha quindi bisogno di essere esplicitato e la sua validità dimostrata. Esiste e basta. Per questa ragione quando persone come me ed altri introducono paradigmi diversi, le reazioni sono di discredito e di forte opposizione. Si parla allora di violenza epistemica. Il cambiamento di paradigma avviene attraverso una rivoluzione scientifica che può sfociare nel cambiamento del paradigma dominante, ovvero quello di riferimento, oppure nella formazione parallela di paradigmi minoritari, portati avanti da soggetti e sottodiscipline che hanno una visibilità e una legittimità inferiore e necessitano quindi un continuo sforzo per affermarne la propria credibilità e veridicità.
2 Grosfoguel, Ramon (2016), Entretien, “RED”, 1, http://reseaudecolonial.org/2016/09/02/entretien/
3 «In contesto di benvedenza, si chiama sbaglieranza la presa di posizione di una compagna a voler agire pur non essendo sicura che vada bene. La sbaglieranza di pratica in terreno scivoloso, quando ogni azione potrebbe esporre la sbaglierante a critiche più o meno forti, più o meno durature. La sbaglieranza fa riferimento ad un’azione fatta come tentativo sperimentale di creare altri mondi, di fare micro politiche che seguano il processo di decostruzione di una realtà data. La possibilità di diventare sbaglierante è direttamente proporzionale alla benvedenza delle compagne e ad una presa di responsabilità collettiva che parte dalla considerazione che “chi fa sbaglia”. La sbaglieranza si pratica a scale, in particolare a cerchi concentrici. Si chiamano cerchi di fiducia quelli costruiti in uno spazio benvedente. Si dice che sia questo il terreno più propizio alla sbaglieranza, nel momento in cui la sbaglierante è sempre in postura di messa in discussione di sé individuale e collettiva» (Wittig fan clubba (2018), Brugliona, Campo Politico Femminista Agape, 21-28 luglio).