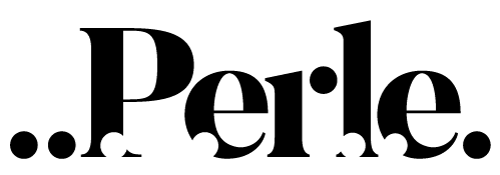Marco Reggio e Elisa Valenti. Animali in gabbia
Pubblichiamo qui un articolo di Marco Reggio ed Elisa Valenti comparso recentemente sulla rivista online Ibridamenti/Due. Il testo, appoggiandosi alle riflessioni di diverse autrici come Michel Foucault, Simone Browne e Sarat Colling, analizza le continuità esistenti tra le pratiche di reclusione e sorveglianza umama e non umana a partire dai regimi carcerari e soffermandosi sulle azioni di resistenza animale e sul tema dell’evasione e della fuga. Ringraziamo Ibridamenti/Due per la possibilità concessa.
Tracciare una linea nera sul panopticon
Nella prima pagina di Sorvegliare e punire Michel Foucault racconta la condanna a morte per mezzo dello squartamento di Robert-François Damiens, colpevole di aver tentato di uccidere il re Luigi XV. Damiens venne ustionato, sventrato, smembrato e infine, forse ancora in vita, gettato su un rogo. Così si puniva un regicida nel 1757.
Foucault apre il suo libro con la brutale esecuzione pubblica di Damiens per impostare, in netto contrasto, la sua argomentazione sulla scomparsa della sofferenza fisica come elemento costitutivo della pena, sostituita dal panopticon, una struttura architettonica carceraria ideata da Jeremy Bentham, che permette a un osservatore non visto di sorvegliare a 360° un gruppo che, inconsapevole della presenza o meno dei sorveglianti, si comporterà come se fosse sempre osservato. Il panopticon segna dunque il passaggio da un potere sovrano che si manifesta con una forza scatenata a un potere quasi divino che vede tutto senza essere visto.
Nel suo libro Materie oscure / Dark Matters. Sulla sorveglianza della nerezza, Simone Browne nota come durante la concettualizzazione del panopticon Bentham abbia viaggiato in una nave schiavista, «una prigione mobile marittima in un momento storico in cui la prigione moderna non era ancora stata istituita sulla terraferma» (p. 70). In anticipo rispetto a Bentham, le persone nere erano già oggetto di istituzioni disciplinari:
«i bambini, le donne e gli uomini neri erano soggetti a questi strumenti molto semplici ma terribilmente violenti: ferri da marchiatura fatti di filo d’argento, registri delle navi in cui le vite delle persone africane erano registrate come unità di carico da trasportare, o inserite negli elenchi degli avvisi di vendita all’asta insieme al bestiame, e ancora categorie di censimento e registri di proprietà e inventari delle piantagioni che catalogavano gli schiavi come merce. La marchiatura degli schiavi come mezzo per contabilizzare il carico delle navi, ad esempio, non era solo individualizzante ma anche una pratica “massificante”, che costituiva una nuova categoria di soggetto: la nerezza vendibile come merce nell’emisfero occidentale» (p. 69).
Browne contrappone quindi al supplizio di Damiens un’altra esecuzione pubblica, quella di Marie-Joseph Angélique, avvenuta nel 1734. Schiava di origini portoghesi, Angélique aveva provato ripetutamente a fuggire dalla sua padrona, con la quale si relazionava in modo tanto insolente e conflittuale che quest’ultima aveva deciso di venderla. Alla vigilia della cessione, tuttavia, un incendio distrusse gran parte di Montreal. Nonostante la sua dichiarazione di innocenza, Marie-Joseph Angélique – donna, nera, schiava – fu condannata e impiccata.
A differenza di Damiens – l’ultima persona in Francia a essere squartata – la storia di Angélique non ha un carattere di cesura con il passato, ma si pone in continuità con la violenza sistematica sulle persone nere. L’uccisione di Angélique è quindi una delle tante storie di criminalizzazione delle donne nere che resistevano e si opponevano alla prigionia, mentre la spettacolarizzazione della sua morte ribadisce quanto fosse sacrificabile. Come già la condanna a pene esemplari, anche il panopticon ha fallito nel produrre individui docili.
In un regime in cui si controllano i corpi dei condannati, lo spazio che possono occupare e la loro libertà, anche la resistenza usa il corpo. La testimonianza di Lorna Rhodes citata da Browne racconta delle forme di resistenza dei corpi nelle celle di isolamento delle carceri dello Stato di Washington: «i comportamenti aggressivi (lancio di feci, urina e altri fluidi corporei), la resistenza passiva (come il rifiuto di mangiare) e l’autolesionismo come casi in cui il corpo è usato come mezzo di resistenza» (pp. 66-67).
Resistenza animale: il corpo ontologicamente insicuro
Quando, anni fa, un gruppo di attivistə ha iniziato a studiare e, soprattutto, documentare la capacità di ribellarsi degli animali non umani dando vita all’archivio del progetto Resistenza animale, non era così chiaro che la questione carceraria avrebbe attraversato costantemente questo lavoro. La cosa più immediata, allora, era mostrare che i non umani si ribellano eccome, che possiedono diverse forme di agency, non meno degne di tale nome delle capacità di rivolta tradizionalmente associate all’umano. Ogni giorno, essi tentano di scavalcare i recinti degli allevamenti, fuggono dai camion che li stanno conducendo al mattatoio, aggrediscono gli addestratori nei circhi o i custodi negli zoo, e quando la situazione è senza speranze esprimono il proprio disagio, la propria disperazione con il linguaggio del corpo, con tutto un apparato di stereotipie, autolesionismi, richieste di aiuto che sono facile preda dei meccanismi di patologizzazione, molto comodi per non vedere la natura politica del sintomo
Il lancio di feci e urina o il rifiuto di alimentarsi, raccontati da Browne per testimoniare della lotta al e nel complesso carcerario statunitense (un proseguimento della schiavitù con altri mezzi, come ha insegnato, fra le altre, Angela Davis), ricordano in modo impressionante la manifestazione del disagio degli animali negli zoo e in altri luoghi, una disperazione che viene spesso derubricata, con sconcertante facilità, a stranezza individuale o a comica bizzarria. E ancora più illuminante è la descrizione del progetto della nave schiavista (una “prigione mobile marittima” che prende forma prima del panopticon). Gli schiavi sdraiati in posizione prona, in modo da occupare tutto lo spazio disponibile; i calcoli sul tasso di mortalità accettabile durante il viaggio (circa l’8%); lo spazio (80 cm) a disposizione di ciascuno schiavo; la suddivisione tra uomini, donne e bambini, stipati in zone distinte e con i soli uomini incatenati fra loro; le precauzioni per salvaguardare la “salute” della “merce” (gli schiavi erano sdraiati sul lato destro perché questo si supponeva che favorisse la funzionalità cardiaca); la razionalità di queste complesse tecniche, esplicitamente architettate per non far sentire i trasportati dei “passeggeri”, ma, al contrario, farli sbarcare consapevoli di essere schiavi; la possibilità di aumentarne il numero disponendoli “a cucchiaio” (a due a due, l’uno disteso all’interno della gambe ricurve dell’altro); le disposizioni per fiaccare ogni piccola forma di resistenza individuale o collettiva: tutto evoca le modalità di trasporto degli animali non umani in un regime di produzione intensiva e, al tempo stesso, definisce uno spazio carcerario.
Occorre poi esaminare l’altra grande pratica di resistenza degli animali, costituita dall’evasione. La fuga dal camion, dall’allevamento o dal tendone del circo è infatti un fenomeno molto comune, nella sostanza spesso destinato al fallimento. Tuttavia, se prendiamo in esame con maggiore attenzione le storie di questi fallimenti, possiamo vedere in dettaglio in che modo la supremazia umana – una locuzione che, come “specismo” o “antropocentrismo”, suona troppo spesso come un concetto smaterializzato – circonda questi corpi disinnescandone il desiderio di libertà, depoliticizzandolo, ridicolizzandolo e ostacolandolo ad ogni passo.
Secondo Jason Hribal, 1 uno dei principali studiosi della ribellione animale, l’intera storia della zootecnia è attraversata da una lotta senza tregua fra controllo e resistenza, quantomeno a partire dalla rivoluzione industriale:
«Siepi e recinzioni vennero erette per impedire la fuga degli animali. Strumenti crudeli, come i gioghi di legno e gli zoccoli, erano intesi a ridurne le possibilità di movimento. Lo sperone, le briglie e il morso, la frusta e il bull-whacker (una mazza chiodata) servivano tutti a provocare dolore. Si diffusero inoltre manuali tecnici che insegnavano l’arte di “stroncare” [breaking] la resistenza degli animali. Furono messe taglie sugli evasi. Vennero costruite gabbie per rinchiudervi quelli che venivano ripresi. I proprietari tagliavano le ali, accecavano gli animali e recidevano loro i tendini. Li castravano e li sterilizzavano. Le corna venivano tagliate. Ciascuna di queste pratiche venne perfezionata e standardizzata. E per gli individui la cui renitenza era indomabile, era prevista una misura definitiva: la pena capitale. I resistenti venivano impiccati alle forche delle città o ai rami degli alberi delle foreste circostanti. I ribelli venivano tormentati a morte durante gli spettacoli e le feste. Agli evasi e agli individui che vivevano autonomamente sul territorio si sparava a vista. Si trattava di pubbliche esecuzioni: brutali nei metodi, eloquenti nell’ostentazione della violenza, determinate a sortire un effetto preciso. La violenza della società nei confronti degli animali divenne una violenza istituzionalizzata» (p. 39).
Oggi, possiamo esaminare il caso degli animali “da reddito” che evadono irrompendo nelle strade urbane, come ha fatto la studiosa Sarat Colling, che nel suo Animali in rivolta. Confini, resistenza e solidarietà umana ha raccontato da una prospettiva femminista decoloniale le fughe dei bovini nelle città nordamericane. I corpi animali che corrono per le vie, cercando di sottrarsi a un destino comune a milioni, miliardi di loro compagnə, sono corpi fuori luogo, eventi del tutto inattesi in un ambiente progettato per altri soggetti e altre pratiche, un ambiente che, mentre sempre più spesso è disegnato per escludere senza tetto, migranti, soggetti umani a vario titolo “indecorosi”, è a maggior ragione a misura di una sola specie, quella umana.
«Quando gli animali fuggono, entrano in gioco altri dispositivi il cui scopo è quello di vanificare le ribellioni. Si tratta di dispositivi che investono in modo più ampio la costruzione di una società come società umana e che mostrano il posto che ai non umani è riservato nell’organizzazione della vita e della produzione. Chi, grazie a un incidente, riesce a scappare dal camion che lo sta portando al macello, trova intorno a sé, per prima cosa, un territorio a misura d’uomo, inadatto alla sua sopravvivenza, un territorio funzionale alla sola comunità umana in ogni suo metro quadro, dalle strade asfaltate con tutte le loro barriere e le automobili lanciate ad alta velocità all’inaccessibilità delle risorse primarie come le fonti di acqua e di cibo, recintate, privatizzate, cementificate. Dovrà poi fare i conti con la densità abitativa umana, talmente alta da implicare un potenziale di vigilanza e controllo capillare (pressoché assoluto) sui latitanti. Senza contare che la selezione genetica, unitamente all’abitudine alla cattività, opera anche in questo caso. Gli animali “da reddito” sono di norma meno adatti dei loro progenitori alla vita selvatica, e al di fuori delle strutture gestite dagli umani raramente sono in grado di sopravvivere: per esempio, al di fuori del recinto non troveranno libere comunità di membri della loro specie, poiché la loro specie esiste soltanto negli allevamenti; troveranno, anche fuori dalle città, un ambiente inadatto alle loro capacità motorie, cognitive ed etologiche. E se questi dispositivi non funzionano o funzionano in modo insufficiente, interviene la repressione intenzionale delle istituzioni umane, un meccanismo che si innesca a partire dalla necessità di tutelare l’incolumità pubblica nell’immediato (pericoli di incidenti stradali, danni alle colture, allarme sociale), ma che di fatto agisce ricacciando nella sfera dell’inesistenza i tentativi di evasione» (Resistenza animale, A fianco di chi si ribella)
Uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro la resistenza animale è, evidentemente, la patologizzazione del dissenso, un dispositivo che ha una lunga storia e che si sviluppa anche, non a caso, nel periodo schiavista in relazione al trattamento degli schiavi umani. Nel 1851 Samuel Adolphus Cartwright, un medico vissuto in Mississippi e Louisiana, nel suo Rapporto sulle malattie e le caratteristiche fisiche della razza Negra descrive una patologia cui dà il nome di drapetomania, la malattia che causa la fuga degli schiavi. “L’irresistibile voglia di scappare” può sembrare un costrutto antiquato, residuale, ma ovviamente a metà Ottocento si inserisce perfettamente nello spirito dell’epoca e concorre a ispirare il razzismo scientifico. Il semplice desiderio della libertà da parte di un individuo in catene necessitava di una spiegazione, di un’eziologia che rimandasse ad altro. Probabilmente, una cattiva gestione dello schiavo, qualcosa che il padrone non sapeva fare nel modo opportuno; ma soprattutto una malattia, appunto.
Come spiega il medico,
«drapetomania deriva dal greco drāpétēs , che significa fuggitivo, schiavo in fuga e da mania, che significa follia, pazzia. È sconosciuta alle nostre autorità sanitarie, benché il suo sintomo, ossia il sottrarsi al lavoro, sia ben noto ai nostri piantatori e soprastanti, come lo era nella Grecia antica che nel solo termine di drāpétēs condensò il darsi alla latitanza e la relazione del fuggiasco con la persona da cui fuggiva. Ho aggiunto alla parola che designa lo schiavo in fuga un’altra parola greca per significare che quella che lo spinge ad allontanarsi è una malattia mentale». 2
La ricetta, per Cartwright, risiede in un trattamento autoritario che non sconfini però nel maltrattamento. Gli schiavi devono essere abituati a inginocchiarsi, a obbedire, senza pretendere autonomia, ma al tempo stesso devono essere «trattati con gentilezza, ben nutriti e vestiti, con combustibile sufficiente a tenere acceso un piccolo fuoco di notte». 3
Oggi probabilmente la chiameremmo, appunto, patologizzazione del dissenso e, almeno in termini così espliciti, ne individueremmo subito il carattere poco scientifico (e molto ideologico). Eppure, se cambiamo il soggetto, osservando come vengono narrate le fughe dei non umani, lo scenario muta radicalmente: considerare il desiderio di libertà una forma di disturbo mentale o di fissazione patologica non ci sembra così stravagante o superato. Quando si tratta di animali, l’ordine del discorso non sembra poi così distante da quello degli stati schiavisti dell’epoca di Cartwright.
D’altra parte, la patologizzazione non è certo l’unica forma di sorveglianza degli schiavi che si sviluppa nei secoli XVIII e XIX. Browne mette in luce il processo di emergenza di un sistema di marchiature, forme di identificazione, avvisi di fuga, lasciapassare che costituiranno la base per le moderne forme di individuazione biometrica e controllo capillare (nonché razzializzato). Questi sistemi hanno come effetto qualcosa che precorre il panopticon, nel senso che il soggetto vive interiorizzando la propria visibilizzazione totale. Il momento emblematico di questo processo è, secondo Browne, la legge sulle lanterne a New York.
Successivamente alla rivolta del 1712, in cui 23 schiavi africani incendiarono un edificio e uccisero e ferirono alcune persone bianche, furono promulgate diverse leggi che rendevano ancora più restrittive le condizioni di vita delle persone nere, indigene e meticce, con lo scopo di neutralizzare possibili nuove insurrezioni future. Si proibirono i giochi domenicali tra persone schiave se questi coinvolgevano tre o più persone; si limitò il numero di partecipanti alle sepolture delle persone nere a un massimo di dodici persone; ma soprattutto il consiglio comunale di New York approvò una legge che obbligava le persone nere, meticce e indigene a portare con sé una lanterna dopo il tramonto affinché potessero sempre essere visibili e identificabili, pena pesantissime punizioni corporali.
La lanterna, dunque, si prefigurava come un’elementare tecnologia di sorveglianza che etichettava le persone nere, meticce e indigene come rischi per la sicurezza e affidava all’intera cittadinanza bianca il potere di controllare le persone sospette.
Le lanterne, in un regime di visibilità opprimente, sembrano essere esattamente quello che per i bovini e altri animali al pascolo sono i campanacci al collo. Che effetto ottiene l’uso costante del campanaccio su un animale? Che modificazioni induce nella psiche del soggetto la percezione, più o meno esplicita, di essere sempre udibile? Di essere sempre individuabile nello spazio? Nella critica animalista e antispecista, attenta alle svariate forme di violazione dei bisogni degli animali, non c’è traccia della questione, forse anche perché essa riguarda una nicchia di sfruttati percepiti come “più fortunati”, le mucche degli allevamenti estensivi.
Browne parla di «corpo reso fuori luogo, o reso ontologicamente insicuro» (p. 175). Le modalità con cui il controllo penetra nella psiche e i segni che lascia sul corpo, tuttavia, ci portano anche a riflettere sulle differenze fra la sorveglianza degli schiavi umani e più in generale i regimi carcerari, da una parte, e la reclusione degli animali non umani, dall’altra.
Il carcere, per esempio, oltre che un sistema di sorveglianza, è un mondo legato a molteplici discorsi che innervano la società umana, ed è esso stesso un discorso. Basti pensare al dibattito sul suo scopo: dispositivo di deterrenza, di rieducazione, o di risarcimento simbolico delle vittime in forma di vendetta? Sorvegliare e/o punire? Occorre sempre tenere a mente che questa saturazione di significati, che investe anche le persone ristrette (continuamente spinte a far proprio il registro dell’espiazione, del pagamento del “debito” con la società, del pentimento), è in buona parte estranea alla contenzione degli animali. Del resto, non è un caso che spesso la propaganda animalista meno avvertita politicamente sottolinei in modo insistente la “non colpevolezza” dei non umani, reclusi “senza aver commesso alcun crimine”, implicitamente avallando il sistema carcerario umano e il concetto ordinario di “criminalità”.
Se però questa differenza sembra lampante quando si utilizza l’analogia del carcere per denunciare la violenza degli allevamenti, a partire dal differente scopo di queste due istituzioni totali, appare un po’ meno marcata quando pensiamo alle campagne governative o degli amministratori locali contro gli animali selvatici. Il ricorrente “allarme cinghiali” o quello relativo ai lupi in certe zone, cui seguono condanne a morte di massa pronunciate da sindaci e governatori ed eseguite dai cacciatori, è in tal senso emblematico perché mobilita discorsi relativi al pericolo sociale, al rischio legato alla presenza libera sul territorio di soggetti che non rispettano le regole, i confini umani o la nostra idea di ordine spaziale. Ancora più emblematico è il noto caso degli orsi trentini, che effettivamente, a seguito di campagne a tutti gli effetti di tipo securitario, da tempo finiscono per essere rinchiusi in una struttura, il Casteller, che ha tutte le caratteristiche della prigione.
Per seguire la parabola di creazione delle condizioni problematiche, elaborazione della figura pubblica del “mostro”, persecuzione del fuggiasco e internamento, è sufficiente ripercorrere la storia di uno dei “mostri” più famosi nella controversia relativa alle politiche trentine di reintroduzione/repressione degli orsi sul territorio: M49.
Stop Casteller
Il 7 settembre 2020 M49 viene catturato per la terza volta. In pochi mesi era riuscito a evadere dalla sua prigione per ben due volte: uno smacco incredibile alle autorità, ancora più grave per il fatto che M49 non è neanche umano. M49 è un orso e sulla sua testa pende un mandato di cattura per essersi cibato di pecore destinate al consumo umano e per aver violato e danneggiato la proprietà privata di agricoltori e allevatori.
Come spesso accade durante l’arresto di latitanti famosi, anche la cattura di M49 viene spettacolarizzata. Viene trasportato trionfalmente sul bagagliaio scoperto di una jeep, esibito come un trofeo di caccia da un gruppo di uomini con il fucile in bella vista. È una rappresentazione di machismo, in cui viene mostrata tutta l’arroganza e la voglia di rivalsa contro un individuo considerato inferiore che ha ridicolizzato i suoi carcerieri con le sue continue fughe. Catturato infatti la prima volta nell’estate del 2019, M49 era rimasto nella prigione del Casteller soltanto un’ora, scavalcando una rete elettrica alta quattro metri. Ricatturato nove mesi più tardi, si era fatto beffe ancora una volta dei suoi carcerieri, che questa volta avevano predisposto misure di sicurezza ancora più imponenti. Castrato chimicamente e munito di radiocollare, attorniato da una barriera elettrica rinforzata, a sua volta circondata da un’altra alta recinzione sorvegliata dalle telecamere, riesce ad evadere dopo tre mesi.
M49 non è solo. Reclusi con lui al Casteller si trovano attualmente l’orso MJ5, che ha ferito un uomo a passeggio con il cane in un bosco, e l’orsa JJ4, che ha attaccato e ucciso un runner che correva in montagna. E ancora prima di loro la prigionia di M49 si incrocia con quella dell’orsa DJ3, anch’essa colpevole di aver predato una pecora e poi deportata in uno zoo in Germania, e dell’orso M57, che per un attacco a un carabiniere che di notte si era avvicinato imprudentemente a lui, è stato catturato e dopo circa un anno e mezzo deportato in uno zoo-safari in Ungheria.
Si può vedere bene che i crimini degli orsi sono lo specchio delle mancanze di un’amministrazione che, dopo averne introdotti dieci negli anni Novanta con il progetto Life Ursus (la specie era quasi assente da secoli sull’arco alpino), ha abbandonato negli anni Dieci le iniziative di educazione nei confronti della popolazione e dei visitatori previste all’inizio del progetto. Tuttavia, nonostante le chiare responsabilità della Provincia Autonoma di Trento, alcuni settori dell’associazionismo animalista più protezionista hanno sottolineato con forza che il trattamento riservato agli orsi non era “giustificato” dalle colpe di questi ultimi, ingaggiando spesso una polemica infinita e talvolta approssimativa sull’accertamento dei fatti: “non è dimostrato che il tale orso abbia davvero invaso la proprietà”, “non è stato lui ad aggredire per primo”, “non è lui il colpevole, potrebbe essere un altro orso”, e così via. Il carattere emergenziale della situazione e il livello di violenza istituzionale non ha permesso di evitare il ricorso ad argomenti che potrebbero rivelarsi dei boomerang poiché legittimano, talvolta in modo lapalissiano, l’idea che un colpevole ci sia e, tutto sommato, meriti di stare dietro le sbarre. Nelle versioni più soft, talvolta comprensibilmente adottate anche da gruppi più radicali, l’argomento decisivo sembra essere quello che fa notare che M49, M57 e gli altri attualmente rinchiusi o ricercati sono perseguitati senza aver commesso alcun crimine. Questa logica sottende spesso l’idea che gli orsi accusati nei singoli episodi siano innocenti, e i veri colpevoli, implicitamente, meriterebbero di essere puniti. Ma quale crimine – anche nel consesso umano – potrebbe giustificare un trattamento così degradante e violento? Quale crimine giustifica la pena di morte o l’ergastolo ostativo? E il carcere in generale?
Un altro meccanismo che chi è sensibile alle sorti degli orsi tende a riprodurre è quello della grazia. Come ha fatto notare Sarat Colling, quando un animale evade e attraversa gli spazi pubblici umani trovando visibilità, fioriscono le reazioni di solidarietà da parte di settori dell’opinione pubblica spesso ben più ampi degli ambienti propriamente animalisti o antispecisti. Queste espressioni di empatia dimostrano le potenzialità positive della resistenza animale, in grado di rompere, sia pur provvisoriamente, la dissonanza cognitiva che ci permette quotidianamente di “amare” gli animali proprio mentre ci cibiamo dei loro corpi.
A volte persone non politicizzate contribuiscono al benessere degli animali interessandosi al loro destino, ad esempio nel caso della mucca Teresa. Ma, come fa notare sempre Colling, spesso la solidarietà è effimera, ed è frutto di un processo di spettacolarizzazione. La mucca o il maiale che durante la corsa disperata per le vie della città viene ripresa dai cellulari dei passanti, generando video virali o articoli diffusi dai quotidiani locali, diventa un esemplare unico, la cui eccezionalità merita interventi straordinari. Ma al tempo stesso «[la] grazia concessa alla singola mucca riafferma la normalità del trattamento a cui sono sottoposti miliardi di animali negli allevamenti e nei macelli» (Marco Reggio, Cospirazione animale, pp. 143-4).
Il potere che mette in atto la grazia non viene messo in discussione da questo provvedimento: Teresa è semplicemente un’anomalia. Del resto, anche in ambito umano, lo strumento giuridico della grazia prevede un atto eccezionale e soprattutto individuale, che non intacca il regime di gerarchia e oppressione generale. Ad esempio, quando viene concessa la cittadinanza a un clandestino che si è distinto per un particolare atto di eroismo, o quando un capo di stato perdona un ergastolano che implora clemenza. Così, fra gli orsi trentini ne è emerso uno, M49, distintosi per coraggio e caparbietà.
Se l’enorme simpatia che essi suscitano può portare a dei risultati insperati per loro, non dobbiamo dimenticare che fra le montagne, muti per chi non sa ascoltare, sopravvivono sotto la costante minaccia della ritorsione di stato decine di altri orsi meno famosi, ma anche centinaia di lupi, cinghiali, nutrie e altre specie di volta in volta etichettate come “invasive”.
Vendetta di stato
Ci sembra necessario, a questo punto, tornare alla materialità della prigione. Il 21 Settembre del 2020, due settimane dopo l’ultima cattura di M49, i carabinieri forestali del CITES svolgevano un’ispezione per monitorare la condizione degli orsi detenuti. La relazione, che esamina anche le annotazioni dei veterinari, è un’agghiacciante cronaca della sofferenza e del progressivo degrado psico-fisico dei tre prigionieri il cui registro medico-etologico, pur freddo e distaccato, suscita un’angoscia e una tristezza immense, come si può vedere da un breve passaggio della relazione:
«Nell’arco di 48 ore la situazione ha subito un grave peggioramento. Tutti e tre gli orsi versano in una situazione di stress psico-fisico molto severa, dovuta in primis alla forzata e stretta convivenza dei tre esemplari, contrariamente a quanto permette la base etologica di specie ed alle ridotte dimensioni degli spazi a disposizione. M49 ha smesso di alimentarsi e scarica tutte le sue energie contro la saracinesca della tana. Reagisce in maniera nervosa alla presenza umana. M57 si alimenta, ma ripete costantemente dei movimenti in maniera ritmata, prodromo di stereotipia. Presenta anche lesione cutanea nell’avambraccio sinistro, dovuto allo sfregamento nell’attività di cui sopra. DJ3, a causa della presenza e degli atteggiamenti degli altri due esemplari, spaventata, si è nascosta nel boschetto del recinto esterno, e non torna in tana per alimentarsi. A questo si aggiunge l’imminente inizio dei lavori della costruzione delle gabbie di tana 2 e tana 3. Vista la delicata situazione si decide di somministrare per la prima volta dalla loro detenzione al Casteller dell’alprazolam (ansiolitico) a M49 e M57 per ridurre lo stato di stress, finché si concluderanno i lavori di costruzione delle gabbie».
Possiamo confrontare questo testo con la testimonianza di un detenuto umano, anch’egli oggetto della vendetta di Stato. Durante l’udienza del 19 giugno 2023 presso la corte d’assise d’appello di Torino Alfredo Cospito dichiara:
«Certe volte ho il dubbio che è il sistema stesso che voglia essere raccontato, perché altrimenti trasferirmi a Opera in quello che Nordio ha avuto il coraggio di definire come una struttura medica di eccellenza? Un caotico e mortale baraccone dove vecchi e moribondi vengono parcheggiati in solitudine in attesa della morte. In questa sottospecie di manicomio nei corridoi piove, l’estate si muore dal caldo, l’aria condizionata non funziona, l’inverno si muore dal freddo. Alle finestre bocche di lupo, scarafaggi, formiche, zanzare impazzano tormentando persone allettate, paralizzate, anziani, moribondi, ciechi.
Tra il giugno e l’ottobre del 2022, in un centro clinico che può “ospitare” 12 persone, in sei non ce l’hanno fatta, non sono sopravvissuti. Se si è fortunati qualche giorno od ora prima dalla morte si viene trasferiti in ospedale dove il trattamento è più umano, ma dove si muore sempre tra estranei senza l’affetto dei propri cari. Tutto è sulle spalle dei ragazzi e delle ragazze che si occupano di pulire e si arrabattano tra pannoloni e medicinali, e gli infermieri-e che cercano di fare del loro meglio ma sono in pochi. La dottoressa responsabile scarica la responsabilità sugli infermieri, dandosi spesso per malata, cosa abbastanza imbarazzante. Naturalmente parlando di detenuti in situazioni sanitarie precarie dove basta essere trascurati un tantino in più per vederti scivolare verso la morte, le obiezioni da parte dei malati scarseggiano. Ma qualche detenuto impavido ha protestato e i tribunali gli hanno dato ragione, ma parlando di 41 bis, di un mondo a parte e di figli di un dio minore, tutto è rimasto invariato».
Di fronte alla materialità della vita fra le sbarre, la reclusione appare come un fatto che si applica ai soggetti socialmente costruiti come problematici, indipendentemente dalla loro specie di appartenenza. Non possiamo negare le specificità del carcere umano, da una parte, e delle strutture di detenzione per non umani, dall’altra: ma è indubbio che l’esercizio del potere, con tutto il suo apparato di sorveglianza, criminalizzazione e contenzione, attraversa con estrema disinvoltura i confini di specie, la distinzione fra animali umani e non umani. Un animale in gabbia, in definitiva, non è altro che un animale in gabbia.

1) Jason C. Hribal, Animals, Agency, and Class: Writing the History of Animals from Below, in Human Ecology Review, Vol. 14, No. 1 (Summer 2007), pp. 101-112. Trad. it. di M. Reggio, Animali, agency e classe. La storia degli animali scritta dal basso, in Liberazioni, 18/5, 2014, pp. 32-58.
2) Samuel Cartwright, Report on the Diseases and Physical Peculiarities of the Negro Race, in New Orleans Medical and Surgical Journal, maggio 1851, pp. 691-715. Trad. it. di L. Benevelli e A. Benevelli Bristow, Rapporto sulle malattie e le caratteristiche fisiche della razza Negra, in Psichiatryonline.it, 1 agosto 2020: http://www.psychiatryonline.it/node/8802, consultato 10/10/23.
3) Ibid.