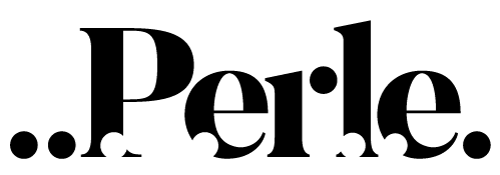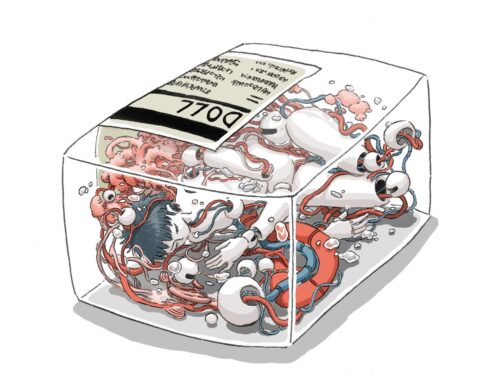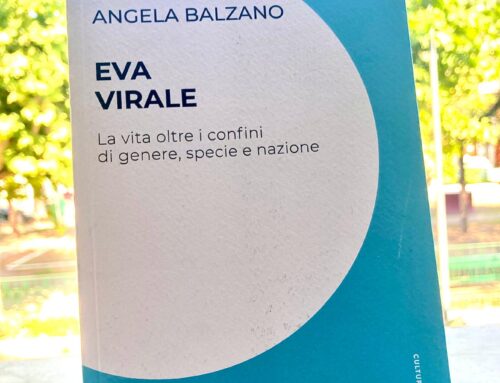Gli esercizi spirituali di Ippolita, di Elvira Federici
Pubblichiamo la recensione di Elvira Federici al volume di Ippolita Hacking del sé (AgenziaX) comparsa sul numero 170 della rivista Leggendaria che ringraziamo per la gentile concessione.
Elvira Federici Gli esercizi spirituali. Un piccolo libro costruito con saggi editi e inediti, nati in periodi e contesti diversi, restituisce il percorso e il lavoro attraverso il quale il Gruppo Ippolita tiene insieme e contamina «il discorso tecnopolitico con le istanze di giustizia sociale transfemminista, decoloniale, antispecista».
La sorpresa è scoprire di tenere tra le mani un prezioso testo per “esercizi spirituali”, – l’associazione va a Pierre Hadot Esercizi spirituali e filosofia antica (2002) – necessari al tempo che viviamo, tempo del capitalismo della sorveglianza esercitata attraverso le tecnologie, cui tuttavia non vogliamo sottrarci senza comprendere e comprender-ci, senza esercitare quella cura del sé, che si interroga sui percorsi di liberazione.
Una sorprendente intimità attraversa questi saggi, nelle XXXII piccole meditazioni introduttive, in cui si portano a tema lo spaesamento intorno a quanto non riusciamo più a riconoscere: la reazione sguaiata invece del dialogo, la perdita del calore dei corpi in una comunicazione sempre più distanziata, l’indistinto tra mondo privato e mondo condiviso, le procedure di gamification, (ludicizzazione) con cui si ottiene l’interesse e il coinvolgimento nella ripetizione.
Non possiamo praticare la cura del sé senza misurarci con questo spazio, il nostro spazio “naturale”, tecnopolitico, «al sorgere di un regime tecnocratico», in cui ci muoviamo, con cui interagiamo e attraverso cui nominiamo la realtà. Ricordando che la mercificazione del vivente «passa anche attraverso dispositivi tecnologici progettati per acquisire una delega sull’organizzazione sociale e cognitiva», Ippolita suggerisce pratiche di sottrazione e di invenzione non individualistica ma relazionale.
Nei 15 passi – capitoli – la meditazione volge alle forme di dominio, alla vita digitale, al rapporto tra corpi e tecniche, al cyborg dei corpi in metamorfosi, al tema dell’inconscio delle macchine e dell’AI, nella dimensione postumana che abbiamo imparato a frequentare attraverso pensatrici femministe e transfemministe: da Donna Haraway di Chtulucene, risalendo fino al cyberfemminismo di Sadie Plant in Zero uno (v. Leggendaria n. 150) Ippolita riprende il tema del “filo conduttore”: corde, intrecci, tentacoli, tessiture in cui la scrittura, il linguaggio, valgono solo nel complesso intreccio con la materia – la presenza dei corpi . Nell’intreccio di corpi, linguaggio, tecnoscienza femminista, si esercita l’etica come ciò che ha a che fare con l’azione politica e la gestione dei rapporti di potere. Il cyborg di Haraway, nella riflessione che anche Braidotti riprende con la sua proposta postumana (v. Leggendaria n. 165) è una metafora del fatto che il funzionamento della materia e quello del linguaggio non è così differente. Transfemminismo, postumanesimo, cyberfemminismo percorrono la strada della non separazione di mente e corpo, di teoria e pratica e quella del «limite ecologico del sé e del mondo».
Al contrario, la deriva tecnocratica (che ha il suo epigono in Elon Mask e nel suo transumanesimo) alimenta con i dati della vita di miliardi di utenti «algoritmi bulimici… Macchine del bisogno al posto di Macchine desideranti». In questo modo si torna a separare (ben più di quanto non faccia Cartesio) il corpo, visto come imperfetto ed inerte contenitore e la mente, liscia, igienizzata, disciplinata. Se la concezione di un’AI, che succhia le vite e le loro energie, rimettendo la specie umana, per la prima volta dopo migliaia di anni, nella condizione di preda, è ciò da cui dobbiamo affrancarci, è pure necessario decostruire l’idea dell’AI come qualcosa al nostro servizio, come produzione di nuova schiavitù per il capitalismo estrattivo dell’era digitale.
Su questo difficile crinale stanno le Ippolite e la proposta dell’hacking del sé.
E dalla forma diaristica, all’antispecismo, alla riflessione sul nostro (occidentale, coloniale) rapporto con la tecnica, si apre il percorso di coscientizzazione: in luogo del potenziamento (biometrico o del game) l’impoteramento; in luogo della produttività, l’ozio creativo; in luogo dell’identità, la disidentificazione (attraverso l’autocoscienza e nuovi immaginari). Infine…kin, il legame tra cose:
«Sentirsi cose fra le cose vuol dire assumere che la reificazione delle nostre vite è onnipervadente. Allo steso tempo significa non arrendersi all’oggettificazione ormai data. Bensì sapersi parte del corpo-mondo cyborg e cercare nuove alleanze possibili tra pari, fra organico e inorganico (…) tra cose-compagne ».
Una ricchissima bibliografia, che spazia dai classici ai poststrutturalisti, alle pensatrici postumaniste e decoloniali accompagna questo libro da portare con sé.
Finestre: Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2002, € 19,00
Elvira Federici, filosofa di formazione e femminista fin dagli anni Settanta, collabora da oltre un decennio con la rivista Leggendaria . Libri, Letture, Linguaggi, seguendo specialmente le pensatrici femministe, transfemministe e decoloniali; è interessata al rapporto epistemologie/potere e allo studio della complessità a partire dal pensiero di Gregory Bateson ; suoi saggi sono pubblicati su riviste e in atti di convegni internazionali. Dal 2020 al 2024 è stata presidente della Società Italiana delle Letterate