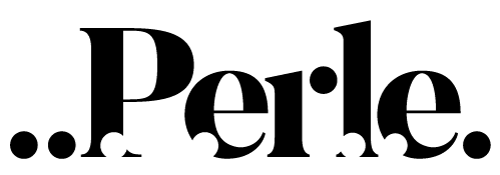Antonio Caronia. Eroi di metallo
Un estratto dal volume di Antonio Caronia, Dal Cyborg al postumeno. Biopolitica del corpo artificiale, a cura di Loretta Borrelli e Fabio Malagnini, Meltemi 2020, collana Culture Radicali. L’estratto è comparso su NOT.
[Immagine: Tomàs Barcelò, Sculpture]
Antonio Caronia. Eroi di metallo. Nel 1836 Edgar Allan Poe scriveva un articolo nel quale tentava di dare una risposta agli interrogativi suscitati dall’apparizione in America del Turco Giocatore di Scacchi. Il Turco era un automa che giocava a scacchi con il pubblico, quasi sempre vincendo, ideato diversi decenni prima in Europa dal barone von Kempelen e portato in America da Maelzel. Ci si chiedeva naturalmente se l’automa fosse veramente una macchina o se ospitasse all’interno, abilmente dissimulato, un uomo. Poe argomenta in favore di questa seconda ipotesi, e lo fa non in modo induttivo, ma deduttivo, enunciando con lucidità un criterio di demarcazione fra uomo e macchina che vale la pena di riportare per intero. Confrontando l’automa di von Kempelen con la macchina calcolatrice di Babbage, da poco costruita, egli scriveva:
«I calcoli aritmetici e algebrici sono per loro stessa natura fissi e determinati. Una volta immessi certi dati, ne conseguono necessariamente e inevitabilmente determinati risultati ( …) Possiamo facilmente concepire la possibilità di organizzare un congegno che, predisposto con i dati del problema da risolvere, dovrebbe procedere in modo regolare, progressivo e costante fino alla soluzione richiesta, poiché i suoi movimenti, per quanto complessi, non possono essere mai immaginati come indefiniti e indeterminati. Il caso, però, è completamente diverso con il Giocatore di Scacchi. In esso non c’è nessuna progressione determinata. Nessuna mossa negli scacchi segue necessariamente un’altra. [In questo gioco] c’è l’incertezza di ogni mossa successiva (…). Non vi è dunque alcuna sorta di analogia tra le operazioni del Giocatore di Scacchi e quelle della macchina calcolatrice di Mr. Babbage (…). È assolutamente certo che le operazioni dell’Automa sono regolate da una mente e da null’altro.»
Poe naviga risolutamente – e non potrebbe essere altrimenti – sulla scia del pensiero moderno, inaugurata dal Cogito di Cartesio: l’uomo è irrimediabilmente e radicalmente separato dal resto del creato grazie al pensiero e al suo prodotto, il linguaggio. Dichiarando la necessità di una mente dietro alle mosse sulla scacchiera Poe ha potuto smascherare il Turco come un falso automa. Grazie all’esistenza del pensiero e del linguaggio Cartesio poteva liberarsi da un dubbio che non ha comunque mai abbandonato l’uomo occidentale (basti pensare, in questo secolo, a Minnie la candida di Bontempelli, oltre che a R.U.R. di Karel Čapek e agli androidi di Isaac Asimov e Philip K. Dick): come essere sicuri che gli altri, che ci appaiono esseri umani come noi, lo siano davvero, e non siano invece macchine perfezionate che simulano un comportamento umano? «Non c’è nessuna delle nostre azioni esterne che possa garantire a coloro che le esaminano che il nostro corpo non sia soltanto una macchina che si muove da sé, ma che, inoltre, ci sia in esso un’anima che ha dei pensieri: nulla, se non le parole o altri segni fatti per qualsiasi cosa si presenti, senza riferirsi a nessuna passione». Anche oggi che i progressi dell’etologia e dell’Intelligenza artificiale rendono più problematiche le sicurezze cartesiane, ci accompagna la presenza discreta, a volte inquietante, a volte divertente, di un doppio meccanico, o elettronico, comunque artificiale, non umano come origine ma para-umano, a volte super-umano, dal punto di vista delle prestazioni.
L’automa moderno, in Hoffmann come in Villiers de l’Isle Adam, in Jean Paul come in Mary Shelley, in Goethe come in Jarry fino alla fantascienza degli anni ’30, ’40 e ’50, affonda la sua ragione d’essere in quell’interrogativo e nelle inquietudini che esso suscita. È un dubbio squisitamente «moderno», nel senso che è inconcepibile senza la nascita della scienza moderna, senza il drastico taglio tra razionalità e irrazionalità, senza la separazione dell’uomo dal suo ambiente e la nascita della nostalgia per la Natura. E tuttavia sbaglieremmo se iscrivessimo le figure dell’automa e del robot, dell’androide e del cyborg (esseri a volte molto diversi, ma che per comodità di esposizione sono stati qui accomunati in una sola categoria) nei ruoli della modernità, come se fossero nati nel secolo dei lumi o, al massimo, alla fine del Medioevo. Moderna è la sensibilità con cui l’uomo si è rapportato con queste figure dell’immaginario: ma esse già esistevano, e anche la loro storia nell’età moderna e nella contemporaneità sarebbe incomprensibile se non ne cogliessimo i tratti che le connotavano nelle società antiche.
In condizioni così mutate, esse conservano qualche caratteristica arcaica, profonda e sedimentata nelle origini dell’immaginario collettivo: del tutto laicizzate, secolarizzate come la società che le ospita, recano ancora i segni del sacro che in altri tempi le attraversava. Ancora una volta la straordinaria sensibilità di Poe ci offre una traccia: il protagonista di un suo racconto umoristico sull’alchimia si chiama proprio come il costruttore dell’automa Giocatore di scacchi (e l’autore stesso suggerisce che si tratti della stessa persona).
Può sembrare a prima vista azzardato ricondurre alla categoria del sacro, a un atteggiamento religioso, per esempio la colomba di Archita (per citare il primo automa «storico» di cui si abbia notizia nella Grecia classica) o le elaborate macchine semoventi, a corda o a vapore, di Erone alessandrino, che tanto interesse dovevano destare nel Rinascimento italiano. Ma una serie di altri dati attenuano il dubbio. L’abilità dell’artigiano, la sua capacità di costruire ordigni e macchine prodigiosi, è celebrata in quasi tutti i miti, simbolizzata nella figura di un fabbro celeste. Il più vicino a noi è il dio del fuoco e della fucinatura della mitologia greca, Efesto (Vulcano a Roma).
Efesto, figlio deforme di Zeus ed Era (Giove e Giunone), è un artigiano robusto e abilissimo. Fabbrica vergini semoventi e tripodi animati, d’oro, per i banchetti degli dei (come si legge nell’Iliade), è il costruttore della prima donna, Pandora, anch’essa un essere artificiale (ne parla uno degli autori più misogini della Grecia classica, Esiodo). Spesso disprezzato dagli altri dei, persino da sua madre che se ne vergogna, (è questo un sintomo della scarsa considerazione in cui la cultura greca tiene le attività tecniche), Efesto mette le sue arti al servizio di una raffinata vendetta, come quando manda in dono a Era un trono semovente che incatena la madre e la porta in giro a suo capriccio, o quando immobilizza la moglie adultera Afrodite e il suo amante Ares (Venere e Marte) con sottilissime corde d’oro. In alcune pitture vascolari greche Efesto è indicato come Dedalo, l’abilissimo ingegnere umano costruttore del labirinto cretese e della vacca di legno nella quale si nasconde la regina Pasifae per congiungersi col toro: da questa unione nascerà il Minotauro. Dedalo fuggirà poi a volo dall’isola col figlio Icaro, con le note tragiche conseguenze.
Nella mitologia germanica la figura di Volundr sembra fondere tratti dell’Efesto e del Dedalo greci. Fabbro e orafo abilissimo, Volundr viene catturato da un re avido dei suoi gioielli, azzoppato e rinchiuso in un’isola. Con l’inganno il fabbro riesce a vendicarsi: uccide i due figli del re, con i loro crani foggia splendidi monili che offre al padre ignaro, poi ne seduce la figlia e infine fugge a volo dall’isola.
Nelle storie dei Narti, leggende raccolte presso la popolazione caucasica degli Osseti all’inizio del secolo e nelle quali Georges Dumézil ha riconosciuto una struttura eccezionalmente ben conservata di antichi miti indoeuropei, esiste pure un «fabbro celeste», Kurdalaegon, il cui intervento ben presto esamineremo. Mircea Eliade, da parte sua, presenta in diverse occasioni figure di fabbri celesti nei miti di popoli africani e oceanici.
Più interessanti però, ai fini del nostro discorso, sono le vere e proprie figure di uomini artificiali presenti nei miti. Gli antichi progenitori, i protouomini, quando ne viene narrata la creazione, appaiono essi stessi come dei prodotti artificiali, esseri nati dal fango o dalla pietra. La creazione di Adamo narrata nel Genesi si collega alla trasformazione in uomini delle pietre che Deucalione e Pirra si gettano dietro le spalle dopo essersi salvati dal diluvio universale, o all’uomo sapiente, Kvasir, di cui si parla nell’Edda di Snorri, formato con lo sputo congiunto degli Asi e dei Vani, gli antichi dei germanici un tempo in guerra e proprio con quello sputo pacificati. Altre volte, come a suggerire una circolarità fra uomo e mondo, è la morte del primo uomo che dà luogo alla materia: nei miti mesopotamici è il seme di Gayomart, l’uomo primordiale, che colando a terra origina i sette metalli conosciuti.
Ma due figure meritano un’attenzione particolare. La prima è il più colossale e prestante fra gli esseri metallici della mitologia greca, Talos, a cui anche Borges ha dedicato un paragrafo del suo Manuale di zoologia fantastica. Talos è un gigante di bronzo, guardiano dell’isola di Creta, attorno alla quale gira tre volte al giorno, scagliando pietre contro gli stranieri e soffocandoli poi in un abbraccio arroventato. Egli è collegato ad altri esseri artificiali che custodivano il santuario di Zeus nell’isola (un cane d’oro, per esempio). Creta è teatro dell’infanzia del re degli dei olimpici, e di alcune delle sue vicende più importanti, come il rapimento di Europa: e anche il nome del gigante ricorda quelli di antiche divinità solari, tanto che anche Zeus veniva chiamato sull’isola Zeus Tallaios. È evidente, per questa via, anche il collegamento con Dedalo, il minotauro e il labirinto. Talos chiude la sua carriera di guardiano ad opera di Medea e degli Argonauti, a cui aveva come il solito tentato di impedire lo sbarco sull’isola: egli infatti aveva un solo punto vulnerabile, il malleolo, a cui giungeva una vena non «metallizzata»: colpita questa, il gigante rovina al suolo con gran fracasso.
La fatale debolezza di Talos, del resto, ricorda quelle analoghe di eroi dei miti e delle leggende eroiche, come Achille o Sigfrido. Uguale destino spetta al più temibile e tempestoso degli eroi Narti, che Dumezil ha avvicinato al dio greco Ares: Batradz. Figlio di uno dei più eminenti guerrieri Narti, ma condannato dalle circostanze della sua nascita a un ’infanzia segregata, da «cenerentolo», Batradz viene al mondo già con un corpo metallico: «Un fuoco rosso passò… era, la metà superiore in acciaio, la metà inferiore in acciaio di Damasco, un bambino che schizzava fuori e andava a cadere in mezzo al mare! La bella acqua blu non fu che una nuvola al di sopra del fondo prosciugato». Ma il suo corpo metallico non gli basta, lo vuole temprato, e allora ricorre al fabbro celeste, Kurdalaegon, che riesce a portare a termine l’opera solo usando carbone di serpenti-draghi, tenendo il fanciullo nella fornace per una settimana e poi lanciandolo in mare, che ancora una volta si asciuga completamente. «Tutto il corpo di Batradz fu di puro acciaio azzurro, salvo un budello, che non fu temprato perché il mare si era asciugato troppo in fretta». Come è facile immaginare, sarà questo budellino ad essergli fatale, dopo una vita di imprese straordinarie.
Saremmo portati oggi a leggere il corpo d’acciaio di Batradz come una metafora interpretata letteralmente, con un procedimento che è tipico della fantascienza; esso rimanda in effetti a una familiarità del corpo dell’uomo con il corpo della terra, a una circolarità fra uomo e natura che è tipica del pensiero mitico. Come ha ampiamente documentato Mircea Eliade, il carattere sacro delle attività metallurgiche riposa su una visione della terra come corpo vivo, e quindi su una concezione «evolutiva» dei metalli, dei minerali, che è la stessa che fonda l’alchimia. I corpi metallici dei giganti e degli eroi tornano così nei sogni iniziatici degli sciamani siberiani, che vedono il proprio corpo smembrato, scarnificato e poi ricomposto con ganci e perni metallici: e di questi sogni conservano il ricordo nei loro costumi carichi di ferro.
L’automa delle società mediterranee classiche, gli eroi metallici dei miti indoeuropei, testimoniano allora una unità primigenia e immediata con la natura, in forza della quale non appare inconcepibile, né spaventosa, la commistione tra il corpo umano e il metallo. Non ancora toccati dalla frenesia baconiana di dominio sulla natura, privi di una teoria e di una pratica della tecnica come «forza produttiva», i Greci per esempio concepiscono i loro automi come manifestazioni di ingegno, come prove dell’eccellenza dei loro inventori. Come non si sarebbero mai sognati di utilizzarli per risparmiare lavoro, per migliorare la «produttività», così non annettevano loro alcun carattere particolarmente spaventevole. Manifestazioni di una presenza divina diffusa, gli eroi di metallo non devono il loro destino tragico (quando lo manifestano) alla loro natura «artificiale», ma al loro ruolo della trama del mito. Non sarà più così quando la fine del Medioevo preparerà rivoluzioni scientifiche, industriali, religiose. Allora la figura dell’automa si trasformerà da compagno benevolo, testimonianza del significato dell’Universo, in doppio inquietante, minaccia per l’uomo, elemento di turbativa del mondo nella sua tragica insensatezza. Non sarà un caso che questo nuovo uomo artificiale, automa o robot, sia un figlio della stessa tecnica moderna che si presenta come la più grande rivoluzione delle forze produttive dai tempi del neolitico.
Ibridi minacciosi
La storia degli automi nell’antichità classica e nel Medioevo è disseminata di riferimenti, tradizioni, leggende: scarsi i documenti. Se però gli autori romani e le riscoperte rinascimentali sono stati in grado di tramandarci almeno alcune delle figure e delle realizzazioni dell’età greca (tutti alessandrini: Ctesibio, Filone, e soprattutto Erone), per quanto riguarda il Medioevo il buio è molto più fitto. La mosca di ferro del vescovo Virgilio di Napoli, l’aquila di Regiomontano che volò incontro all’imperatore a Norimberga, le innumerevoli teste parlanti attribuite a papa Silvestro II, a Roberto Grossatesta, a Ruggero Bacone, il perfezionatissimo androide costruito da Alberto Magno perché lo servisse, e che venne poi distrutto dall’arcigno successore di lui, Tommaso d’Aquino: tutte leggende, che documentano però un interesse forse imprevedibile di quell’epoca per l’essere artificiale. E tuttavia in una società organica come quella medievale, in cui prevale un approccio rigidamente religioso e morale alla realtà, una inflessibile idea di gerarchia, in cui l’attività manuale viene sistematicamente sottovalutata e disprezzata nel sistema di valori dominante, la tecnica non può avere un posto importante nell’immaginario collettivo, e la figura del costruttore di automi non può emergere con autonomia e rilievo.
L’uomo meccanico dell’evo di mezzo (le realizzazioni che ci sono rimaste, s’intende, e non quelle tramandate dalle tradizioni) è perciò principalmente lo «jacquemart» basso-medievale, come i mori di piazza S. Marco a Venezia o il «Maurizio» di Orvieto – per citarne due dei più famosi di casa nostra: un gigante metallico che con il suo martello percuote un campanone di bronzo e scandisce il tempo. Una figura centrale nella vita della città del basso Medioevo, ma ancora molto intrisa di una dimensione sacrale e religiosa. Il legame fra l’automa e l’orologio non è comunque casuale: la simulazione dei movimenti del corpo umano o animale, se vuole essere abbastanza precisa, non può basarsi sugli ingegnosi sistemi di funi e contrappesi con cui sono costruiti gli automi di Erone, ma deve utilizzare i congegni di una meccanica molto più precisa e miniaturizzata (relativamente all’epoca), quelli appunto che gli anonimi artigiani dell’ultima parte del medioevo misero a punto per la costruzione di macchine in grado di scandire un tempo uniforme e misurabile. Ma non c’è solo un problema tecnico: la strada gli automi dell’epoca moderna è aperta anche da una progressiva secolarizzazione delle categorie interpretative.
Da un lato il tempo non è più (o non solo) il tempo della liturgia, la ripetizione sacrale di un tempo mitico come quello della vita di Cristo, ma è (anche) il tempo degli scambi, della vita produttiva, di una dimensione sociale di «tempo libero». E non è un caso che le più complessse realizzazioni della tecnica rinascimentale in fatto di automatismi (tralasciamo, come sempre, le tradizioni di più ardua documentazione come il leone meccanico di Leonardo che avrebbe accolto, a Milano, Luigi di Francia) siano i giardini animati: con le grotte di Pratolino costruite da Bernardo Buontalenti per il Granduca Francesco I di Toscana si inaugura un nuovo «genere» che ha grande successo e diffusione tra il XVI e il XVII secolo, soprattutto in Francia. D’altro lato, anche la nascente anatomia, inaugurata da Andrea Vesalio nelle tavole del De humani corporis fabrica (1543), rinuncia a cercare nel corpo umano la conferma di sacre simbologie a favore di uno studio più concreto delle forme e dei meccanismi di funzionamento. In un’epoca di generale ristrutturazione del sistema simbolico, di sconvolgimento dell’immaginario collettivo vigente, la figura dell’automa non tarda a emergere quasi come simbolo di una riconquistata autonomia dei sistemi di rappresentazione del reale e di dominio sul mondo. Questo accadrà principalmente quando, con l’Illuminismo, si sarà fatta strada nella cultura europea una radicale ipotesi materialista, approdo conseguente delle premesse di valorizzazione e autonomizzazione delle attività umane (tanto teoriche quanto pratiche) emerse con la dissoluzione del mondo medievale. Il XVIII secolo, infatti, celebrerà il definitivo (per il momento) trionfo della tecnica, la sua promozione ad attività umana meritevole di attenzione al pari delle altre, senza più sensi di inferiorità verso le sue sorelle «intellettuali», la ricerca del vero e del bello.
L’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert tratterà per la prima volta il telaio meccanico e la macchina a vapore come oggetti culturali, al pari delle speculazioni filosofiche e delle opere d’arte. Nel contempo si tenta però un nuovo paradigma unificante, capace di ridare unità alle ricerche culturali già frantumate dall’affermarsi delle nuove scienze e dall’eclissi dell’organicismo religioso medievale. Questo paradigma è il materialismo, che passa da filone eccentrico e marginale del pensiero occidentale a fenomeno culturale emergente. Julien Offroy de Lamettrie ne espone, nell’Uomo macchina (1747), il manifesto: radicalizzando le tesi di Cartesio, che aveva affermato che ogni animale era descrivibile come macchina, si riconduce anche il pensiero (almeno in linea di principio) alla materia e al movimento. Ma anche Diderot, pochi anni più tardi, con la Lettera sui ciechi (1749), si avvicina a queste ipotesi. Il materialismo settecentesco, dal punto di vista delle teorie cognitive, è rigorosamente sensista. È a questo proposito che troviamo uno dei più gustosi «automi teorici» o mentali (un automa pensato, cioè, ma non costruito): è la statua che Etienne de Condillac introduce nel suo Trattato delle sensazioni (1754). Ecco la descrizione che ne dà Borges:
«Condillac immaginò una statua di marmo, organizzata e conformata come il corpo di un uomo, e abitazione di un’anima che mai avesse percepito o pensato. Egli comincia col conferire alla statua un solo senso: l’olfatto, forse il meno complesso di tutti. Un odore di gelsomino è il principio della biografia della statua: per un momento non ci sarà che quest’odore nell’universo: o meglio, quest’odore sarà I’universo che, un momento dopo, sarà odore di rosa, e poi di garofano. Che nella coscienza della statua ci sia un solo odore, e avremo già l’attenzione; che l’odore perduri quando è cessato lo stimolo, e avremo la memoria; che un’impressione attuale e una passata occupino insieme l’attenzione della statua, e avremo la comparazione; che la statua percepisca analogie e differenze, e avremo il giudizio (…). Nate così le facoltà dell’intelletto, quelle della volontà sorgeranno dopo: amore e odio (attrazione e repulsione), speranza e timore (…). L’autore conferirà poi al suo uomo ipotetico l’udito, il gusto, la visione, e infine il tatto. Quest’ultimo senso gli rivelerà che esiste lo spazio e che, nello spazio, lui è un corpo: i suoni, gli odori e i colori gli saranno sembrati, prima di questo stadio, semplici modificazioni o variazioni della sua coscienza».
Della statua di Condillac ha fornito recentemente una nuova versione lo scrittore di fantascienza Raphael A. Lafferty. In questo racconto la statua sopravvive al suo costruttore, unendosi a un gruppo di rivoluzionari. Il cattolico anticonformista Lafferty non perde l’occasione per rinfacciare ai razionalisti l’esito sanguinoso della messa in pratica delle loro teorie. «La ragione è quello che conta, Statua, la razionalità. Noi la divulghiamo, ed essa si diffonde. Prevale. Il mondo futuro sarà il mondo della ragione totale,» dice Condillac nel racconto. «No, sarà la Rivoluzione», risponde la statua. «Un mondo condannato alle razioni ridotte della ragione chiederà il sangue a gran voce».
Le «razioni ridotte della ragione», nel XVIII secolo, si raccoglievano attorno al grande paradigma materialista-meccanicista. Tutto l’universo è un grande meccanismo, regolato dalle leggi di Newton (appena allora accettate da tutta la comunità scientifica). All’uomo il compito di conoscere queste leggi, applicarle, dare impulso a un nuovo sviluppo lineare e potenzialmente illimitato delle forze produttive. È in questo clima culturale che va compresa la fioritura eccezionale di automi nel XVIII secolo e, in parte, nel secolo seguente. L’assimilazione dell’uomo alla macchina, avanzata nel campo concettuale, esigeva di essere verificata, tradotta nella pratica, ovviamente nel senso inverso: l’eccellenza della tecnica doveva permettere la costruzione di macchine che simulassero almeno alcune delle funzioni umane – i movimenti, persino la voce. Per la prima volta i costruttori di automi non sono figure solo eccentriche, ma personaggi stabilmente inseriti nel panorama e nelle attività tecniche della loro epoca. L’esempio più chiaro di questa nuova tendenza è proprio il più famoso e geniale costruttore di automi del Settecento, Jacques Vaucanson (1709- 1782).
Costruttore a soli sedici anni di alcuni piccoli automi, a trentadue già Ispettore Generale delle manifatture di Francia, inventore nel 1745 di un telaio automatico più volte da lui stesso perfezionato negli anni seguenti, Vaucanson inseguì per tutta la vita il sogno di un uomo artificiale, capace di riprodurre tutte le funzioni fisiologiche dell’essere umano. Un sogno che accompagna tutta la storia della tecnica in quel secolo, capace di dare origine a ricerche appassionate, sottili tentativi, polemiche arroventate. Pochissimo è dato conoscere di questa ricerca di Vaucanson, se non che essa era strettamente collegata con l’apparizione di una nuova materia prima, il caucciù; il geniale meccanico francese si interessò da vicino ai problemi connessi con la trasportabilità e la malleabilità di questa materia, ma, a parte qualche incerta testimonianza, nulla si sa sulle realizzazioni concrete. Prima e dopo aver lavorato a questo progetto, comunque, Vaucanson costruì tre automi meravigliosi, che, presentati fra il 1738 e il 1739, girarono poi la Francia e tutta l’Europa: un flautista capace di eseguire delle arie su un flauto traverso, un tamburino, e la famosissima anitra, che imitava alla perfezione tutti i movimenti dell’animale, compresa la masticazione del cibo e la deiezione dei rifiuti.
Questi automi (la cui presenza nelle città d’Europa è attestata, per i primi due, fino ai primi dell’Ottocento, per l’anatra addirittura fino al 1863) non sono che i più famosi esemplari di una lunga serie di consimili, costruiti da meccanici meno famosi, ma non per questo meno abili di Vaucanson: dall’austriaco Friedrich von Knaus agli svizzeri Pierre e Henri-Luis Jacquet-Droz (alcuni loro automi, ancora funzionanti, sono conservati nel museo di Neuchâtel), ai francesi Maillardet, tutti operanti nel Settecento, e nell’Ottocento il tedesco Johann Bartholomé Rechsteiner, che ricostruì dopo un secolo l’anatra di Vaucanson fortunosamente ritrovata, l’illusionista Jean- Eugéne Robert-Houdin e Gaston Decamps. Ma il Settecento rimane, naturalmente, il secolo più ricco di automi. Il mito di Prometeo ritorna allora (e non sarà più così nel secolo seguente) nelle forme dello sbalordimento, della meraviglia, con un gusto per il segreto, per gli aspetti riposti della realtà che il positivismo si incaricherà poi di smantellare (pur senza riuscirvi del tutto). E i costruttori di automi, singolari figure di tecnici-inventori-imprenditori (non scienziati, e neppure «tecnologi» nel senso che oggi diamo a questa parola) mostravano di assecondare alla perfezione questo gusto. «Questi androidi erano prima di tutto una fonte di guadagno, venivano pensati e progettati tenendo ben presente il gusto del pubblico, dell’epoca: ecco che questo puntuale rifare aspetti e movenze della vita asseconda ancora un gusto ancora presistente per il magico, il chimerico, l’esoterico: ma che sfociava nella meccanica, però, che trovava la sua radice in un contesto razionale e spiegabile». Il che spiega anche una certa tendenza degli «automatisti» a tenere segreta la spiegazione dei meccanismi delle loro opere, e a ricorrere anche a veri e propri trucchi. Vaucanson stesso, per esempio, non rivelò mai, finché l’anatra era in suo possesso, che la poltiglia presentata come gli escrementi della digestione era in realtà preintrodotta nell’automa, preferendo far credere che fosse il prodotto di una vera e propria simulazione della digestione; e non occorre poi ricordare il caso clamoroso del Turco scacchista di von Kempelen, vera e propria truffa di cui si è parlato nell’articolo precedente.
Ma la disponibilità alla meraviglia, a uno stupore gioioso, dura finché dura l’adesione al paradigma dominante. Altrimenti (per restare in tema) si rischia di rimanere come il Casanova- Sutherland in quella memorabile scena del film di Fellini, in cui l’avventuriero veneziano continua a danzare dignitosamente con la sua dama (un automa) anche quando i meccanismi sono andati fuori registro, ed essa esibisce scompostamente il suo sghembo arto meccanico: scena memorabile, dicevamo, perché senza una parola mostra la crisi e la fine di un’epoca. Il paradigma materialista- meccanicista non rimane incontrastato, in realtà, che poco più di mezzo secolo. Già negli ultimi anni del Settecento esso viene contestato, rovesciato, dalla reazione romantica, con la sua preoccupazione dell’unità Uomo-natura e con la sua critica ai valori (diremmo oggi, con un minimo di forzatura) «tecnocratici» oltreché razionalisti, dell’Illuminismo. È soprattutto negli scritti del romanticismo tedesco, in Ludwig Tieck, in Achim von Arnim, in Jean-Paul, che troviamo espresse queste preoccupazioni. Ed è in loro – piuttosto che negli autori, coevi o di poco precedenti, del filone «gotico» inglese – che la figura dell’automa si trasforma nell’emblema satanico, demoniaco, della «hybris» umana e della sfida che essa lancia all’ordine naturale (o divino, il che per i romantici è quasi sempre lo stesso).
I racconti dei romantici in cui compaiono figure di automi sono stati analizzati, da Otto Rank e successivamente da Freud, e ricondotti alla categoria del «doppio», ombra, riflesso dell’io o vero e proprio sosia dotato non solo di straordinaria rassomiglianza ma di una angosciosa e inestricabile intersezione con la vita del protagonista. L’automa diviene una delle personificazioni del doppio, considerato come «parte inalienabile del proprio passato», ma anche come minaccia rivolta all’io e al valore narcisistico che l’uomo gli attribuisce. Questa minaccia è tanto più angosciosa in quanto viene da una replica inanimata della vita.
«Ho sempre provato un senso di invincibile ripugnanza per quei fantocci costruiti non tanto a immagine e somiglianza dell’uomo, quanto a scimmiesca imitazione del sembiante umano – veri e propri monumenti eretti alla morte in piedi, alla vita mummificata,» dice il protagonista di un racconto di Hoffmann. Proprio Hoffmann è stato «il poeta per eccellenza del tema del Doppio». In uno dei suoi più noti racconti, «Der Sandmann», (L’uomo della sabbia o L’orco insabbia), analizzato da Freud in un famoso saggio, la figura dell’automa appare collegata ai traumi infantili del protagonista. Nataniele, bambino, è ossessionato dalla fiaba dell’Orco Insabbia, che per fare addormentare i fanciulli getta loro manciate di sabbia negli occhi finché questi cadono insanguinati fuori dalle orbite. Egli identifica l’Orco con il misterioso collaboratore del padre, Coppelius, sorta di fabbro/alchimista che, in un incubo (reale? sognato?) minaccia di strappare gli occhi al bambino e gli svita invece mani e piedi. Cresciuto, Nataniele incontra nuovamente Coppelius nelle vesti dell’ottico Coppola: frattanto si è però innamorato di Olimpia, silenziosa figlia del professor Spallanzani, dimenticando la fidanzata. Ma in una furibonda lite tra Spallanzani e Coppola, Nataniele scopre che Olimpia è un essere meccanico, a cui il professore ha dato il meccanismo, Coppola gli occhi (rubati, afferma Spallanzani, proprio a Nataniele). Il giovane impazzisce e, infine, muore gettandosi da una torre. L ’interpretazione di Freud riconduce il terrore dell’accecamento, anche sulla scorta del mito di Edipo, alla paura della castrazione, e interpreta la figura di Olimpia come un «doppio», appena camuffato dalla differenza disesso, di Nataniele. «Questa bambola automatica non può essere altro che la materializzazione dell’atteggiamento femmineo del piccolo Nataniele verso il padre. I padri di Olimpia – Spallanzani e Coppola – non sono che nuove edizioni, reincarnazioni del padre di Nataniele (…). Olimpia è per così dire un complesso distaccatosi da Nataniele che gli si fa incontro come persona; quanto egli sia dominato da questo complesso è espresso nell’insensato e ossessivo amore che egli nutre per Olimpia».
Come sarà più tardi per gli alieni e i mostri della fantascienza, anche l’automa, insomma, non è che una parte di noi. Una parte di noi che suscita orrore, perche è espressione in qualche modo di un passato già concluso e immutabile, fa parte di quei «fenomeni vitali già completamente dispiegati e attuati, privi cioè di ogni “possibilità evolutiva” e visti dunque come manifestazioni diaboliche». Bisognerà attendere settant’anni esatti perché un altro demistificatore del progresso scientifico, Villiers de l’Isle Adam, rovesci questo orrore in sarcasmo e ironia, proponendo (in un contesto di accesa misoginia) la sostituzione della donna naturale, di Eva, con una «Eva scientifica», un androide femminile, appunto la «Andreide». Ma non precorriamo i tempi. Per il momento (cioè nei primi decenni del XIX secolo) prevale ancora l’inquietudine per le forze che la scienza e la tecnica, incontrollate, possono scatenare. Gli automi di Hoffmann e di Jean-Paul, c’è appena bisogno di notarlo, sono stretti parenti della «creatura» del Frankenstein di Mary Shelley (il romanzo è del 1818). Non è dell’automa, naturalmente, che i romantici hanno paura, ma di quello che l’uomo si porta dentro: una forza oscura che assume, inesorabilmente, il nostro viso.
Se vi è una forza oscura che ripone a tradimento nel nostro cuore un filo, col quale poi cerca di trascinarci su strade pericolose e fatali – se esiste una simile forza, allora, dentro di noi, essa deve assumere il nostro aspetto, divenire anzi noi stessi; perché solo così possiamo credere in essa e darle il modo di compiere la sua opera segreta.
Ancora una volta, l’automa è uno specchio.
Antonio Caronia , nato a Genova nel 1944, ha animato il collettivo «Un’ambigua utopia» sull’immaginario politico e fantascientifico. Filosofo, attivista, teorico di sociologia e di estetica dei nuovi media, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, la NABA e il Planetary Collegium di Plymouth. Tra i suoi testi più noti: Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti (1996), Houdini e Faust. Breve storia del cyberpunk (con D. Gallo, 1997), Philip K. Dick. La macchina della paranoia (con D. Gallo, 2006) e Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale (2008).