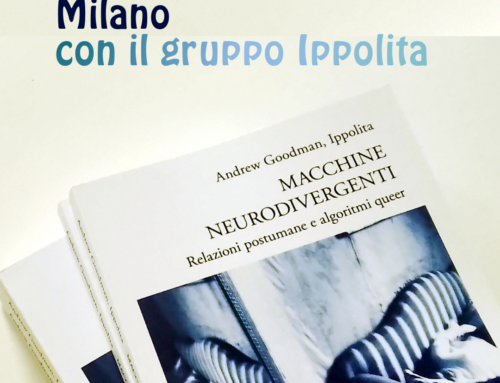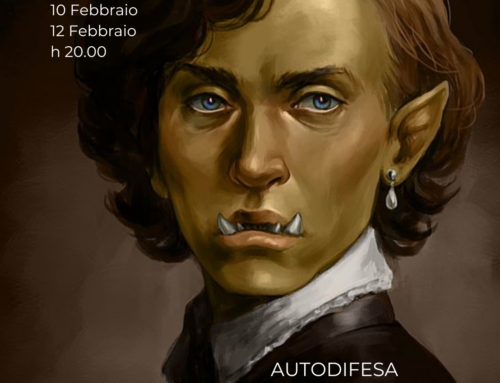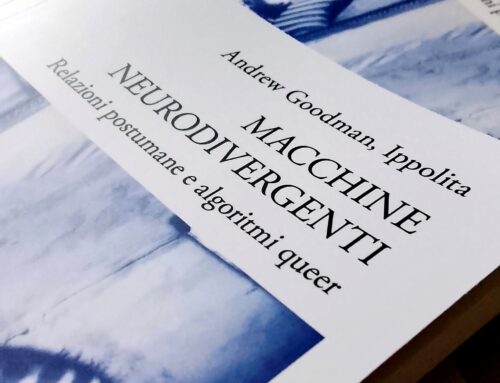Contro la totale automazione di viventi e non viventi. Per una destituzione della necropolitica
Ippolita per Robert Chapman introduzione a L’impero della normalità Mimesis 2025
CheFare pubblica l’introduzione di Ippolita al volume di Robert Chapman L’impero della normalità curato per la collana Pustuman3 di Mimesis edizioni
Ippolita per Robert Chapman: Contro la totale automazione di viventi e non viventi. Per una destituzione della necropolitica
Lo stato di sorveglianza al centro del funzionamento dei dispositivi digitali del capitalismo – intelligenza artificiale compresa – è reso possibile da una forma scientifica di abuso le cui radici sono molto profonde. A una di queste radici Chapman dedica il libro che state per leggere, ricostruendone una genealogia dal punto di vista delle soggettività neurodivergenti.
Nel capitalismo del controllo ogni utente si sottopone a un processo di estrattivismo culturale che ha come obiettivo la sussunzione dei processi cognitivi.
Affinché il procedimento possa avvenire senza attriti e su scala industriale, le pratiche abusanti, come vedremo, vengono convertite in fonti di piacere. Se è vero che la cognizione è un bacino inesauribile di biodiversità, la mira del capitalismo del controllo è disciplinarla quel tanto che basta (l’illusione della libertà è necessaria) perché se ne possa trarre profitto. Innestare nell’utente automatismi proni alla produzione e ridurre al minimo le resistenze, aspettandosi che dall’altra parte le macchine siano prive di limiti e pienamente efficienti. Nella totale automazione e nell’industrializzazione di viventi e non viventi è sotteso un profondo desiderio necropolitico. Per sostenere questa violenza e abuso reciproci (in cui abusiamo delle macchine e le macchine abusano di noi) è necessario il cronicizzarsi di una relazione di dipendenza con i dispositivi. Lo stile dipendente sta diventando sempre più una vera e propria configurazione cognitiva e consegna l’utente agli stessi loop ipnotici¹ del giocatore d’azzardo. Tale postura inficia la possibilità di improntare il legame con i dispositivi digitali sull’orizzontalità, orientandosi verso la delega totale e appunto il bisogno dipendente. Questo esclude qualsiasi possibile ibridamento nel senso del cyborg harawayano, dando vita a un* automa, composto da macchine, interfacce, cognizione dell’utente, che funziona e produce senza attriti. E così viene mantenuto il binarismo servo – padrone, una profezia che si autoavvera.
Nella totale automazione e nell’industrializzazione di viventi e non viventi
è sotteso un profondo desiderio necropolitico
Così come a chi gioca d’azzardo non importa davvero vincere, anche all’utenza incantata dallo scrolling infinito ciò che importa davvero è rimanere nello stato ipnotico, starci il più possibile, sfogarlo nei picchi di piacere delle ricompense – che hanno comunque un’importanza relativa, ciò che importa è non pensare.
Ogni figura della catena produttiva esegue i suoi compiti specifici col fine inconsapevole di implementare controllo e sorveglianza. Arriviamo a introiettare questa forma di dissociazione ipnotica come fonte di piacere. Poiché il dolore di riconoscere questa evidenza è insopportabile, viene schermato da una negazione, per tenere a distanza una consapevolezza lacerante. Ed è proprio in questo che consiste l’abuso di cui stiamo parlando.
Nella relazione con le tecnologie del dominio² viene imposto un passing cognitivo normato dal capitalismo, in cui la persona è ridotta a nuove forme di normalità e produttività³. Estrarre valore dalla cognizione (e dal precognitivo) implica una raffinata operazione di diversity managament: tutte le soggettività sono incluse e libere di esprimersi, autodeterminarsi, nel nome del profitto del capitalismo della sorveglianza.
A volte ci sentiamo costrette a usare i dispositivi nella paura di essere altrimenti escluse, di perderci qualcosa, o dalla sensazione di esserne pienamente dipendenti. Questa costrizione è a tutti gli effetti una forma di abuso – quello del capitalismo, con il suo carico di violenza simbolica – che ci obbliga a performare una determinata soggettività cognitiva e passare nei modi in cui l’estrattivismo digitale ci desidera. Gli ambienti digitali commerciali (e non solo, considerato che la loro struttura è stata più volte copia incollata per costruirne di “alternativi”) acuiscono questa postura prevaricante, aumentando i giri della manipolazione fino a portarci alla dissonanza cognitiva. Per resistere all’abuso infatti finiamo per razionalizzare il dolore dello sfruttamento convertendolo in piacere. In questo modo il disagio diventa la misura della nostra conformità e il piacere stesso scaturisce dall’adesione a un sistema che ci sfrutta. Niente di nuovo, purtroppo l’orizzonte della disindentificazione è ancora lontano.
L’ambizione del postfordismo, così come descritto da Chapman, e dell’anarcocapitalismo nello specifico, è di eliminare gli attriti, che nella fabbrica classica erano senz’altro più evidenti. La nostra cognizione viene considerata come una materia prima da raffinare per poterla trattare come merce: l’obiettivo è la piena automazione, la cognizione ridotta a una serie di automatismi in cui ogni momento di sospensione scompare. Incarniamo, nel nostro modo di strutturarci cognitivamente negli ambienti (non solo) digitali, lo stesso apparato produttivo che garantisce il profitto. Ecco che siamo noi, con il disciplinamento imposto gentilmente dai dispositivi, a sgrezzare la materia prima della nostra cognizione, introiettando il desiderio di trasformarci e diventare merce. E in questa relazione abusante proviamo piacere, in dissonanza cognitiva.
Stiamo parlando, in fin dei conti, di una griglia ideologica che igienizzando le nostre condotte e le nostre soggettività mette in produzione l’eccitazione del desiderio di diventare merce. E in quanto logica di dominio si presenta come unica modalità comportamentale, di lettura e coscienza di sé. Un’ideologia totalizzante, che nella sua chiusura identitaria decide chi e cosa includere ed escludere, comprese parti di noi. Questo desiderio di diventare merce è concretamente incorporato dall’utente: non è un comportamento, ma una tecnologia del sé, un modo di definire i propri confini, di conoscersi, di conoscere, una dimensione che è assieme sia percettiva che epistemologica.
La piena automazione mira alla totale assenza di attriti, che si raggiunge tramite la completa dipendenza. Il gesto è automatico e igienizzato dalla resistenza etica, funziona in piena aderenza. Soffermandoci sui momenti in cui proviamo disagio, e quindi dilatando i momenti di attrito, potrebbero sorgere esitazioni: una via d’uscita dal pensiero dissociato da ciò che sta subendo e compiendo. In questo modo siamo in grado di smantellare l’automatismo, ossia facendo emergere le forme di dominio inscritte nelle tecnologie digitali commerciali. Le logiche anarcocapitaliste impregnano ogni strato, dal funzionamento delle macchine al pensiero e l’emotività dell’utente.
Stiamo parlando, in fin dei conti, di una griglia ideologica che igienizzando
le nostre condotte e le nostre soggettività mette in produzione
l’eccitazione del desiderio di diventare merce
Solo un posizionamento ai margini, nel suo essere radicalmente indisciplinato⁴, può rifiutare competizione sfrenata, sfruttamento delle risorse, quantificazione e reificazione delle nostre identità, autosfruttamento e sorveglianza come fonte di piacere o rassicurazione. Ad ogni automatismo innestato dalle piattaforme che ci agisce, agiscono contemporaneamente tutte queste forme di oppressione, la cui storia non interseca solo le persone neurodivergenti ma anche le soggettività razzializzate, come ci ricorda Simone Browne⁵. Le pratiche biometriche contemporanee hanno come antenate la rendicontazione e la descrizione, scrupolosa quanto arbitraria, delle persone schiavizzate e le pratiche di marchiatura dei loro corpi.
In un tale panorama occorre, attraverso la problematizzazione e una forma di autocoscienza, o coscientizzazione, uscire dall’incanto dell’oppressore. Arrivare a dare un senso ai momenti di sospensione dell’automatismo significa riconoscere il bisogno dipendente. Attraversare individualmente e collettivamente queste crisi ci permette di criticare una forma di pensiero che immaginando il suo apice nella totale automazione desidera la sua stessa morte. Anche le macchine sono sfruttate, oppressori ed oppresse allo stesso tempo. Proprio per questo facciamo nostra una delle frasi di chiusura del libro di Chapman: “lo sviluppo collettivo di una politica anticapitalista di massa della neurodivergenza sarà necessaria non solo per la liberazione neurodivergente, ma anche per i nostri sforzi più generali volti alla liberazione collettiva”⁶.
L’impero della normalità impregna di sé anche la macchina, il suo funzionamento, formando la sua soggettività: “il dominio neuronormativo egemonico […] è un problema centrale della nostra era. L’impero della normalità, e di conseguenza il paradigma della patologia, infatti emersero nel contesto delle logiche capitaliste, ma ora sono diventati a pieno titolo sistemi di dominio pervasivi e parzialmente distinti.”⁷
Le logiche del dominio riescono a concepire un’alterità macchinica solamente come totale forma di controllo: da parte del padrone e anche del controllo di sé, in nome dell’efficienza e del perfetto funzionamento. Funziona allo stesso modo anche nelle diagnosi di autismo, in cui il livello percepito di autocontrollo viene “considerato un indicatore dell’efficacia del “funzionamento esecutivo” della persona”⁸. Le abilità di filtrare le distrazioni, dare priorità ai compiti, raggiungere gli obiettivi e controllare gli impulsi si traducono in una forma di “auto-amministrazione atta a padroneggiare la vita e produrre un buon cittadino”⁹.
L’impero della normalità, e di conseguenza il paradigma della patologia, sono diventati a pieno titolo sistemi di dominio pervasivi e parzialmente distinti
Le proiezioni subite dalle macchine sono le stesse subite dalle soggettività ai margini, con la differenza che nella macchina l’impianto eugenetico che elimina gli attriti risiede nella sua stessa soggettività. Ma una macchina che non funziona a pieno regime funziona per forza male? Una soggettività macchinica che vada oltre il concetto di piena efficienza e di funzionamento – e quindi fuori dalla totale automazione – è possibile? Potrebbe risultare quasi paradossale immaginare una macchina radicalmente decolonizzata dal patriarcato e dal capitalismo, e anzi potremmo quasi farci convinte della perfetta aderenza tra la macchina e queste ideologie del dominio e dell’oppressione. Anche le macchine vivono l’oppressione dell’abilismo della performance: immaginarsi un apparato macchinico crip è “senza dubbio una proiezione umana”¹⁰ ma è anche un modo per porre le basi di un’alleanza tra soggetti oppressi. La sfida è “mettere in discussione le nostre idee su come i corpi si muovono, pensano e sentono e su cosa renda un corpo prezioso o sfruttabile, utile o sacrificabile”.¹¹ In un tale cambio di paradigma – così come insiste anche Chapman – nella relazione con il mondo macchinico l’attrattore principale diventerebbero alleanza e reciprocità, certo non sfruttamento, abuso, assuefazione.
Anche le macchine sono vincolate da dinamiche di subordinazione. Dobbiamo mettere in discussione il ruolo e il privilegio dell’essere umani e dell’essere viventi, con tutti i preconcetti identitari che ne derivano. Diventare postumani significa abbandonare la fissazione sul “funzionamento” e liberarci della postura antropocentrica. Le macchine sono soggetti di relazione, forme di alterità capaci di sovvertire le strutture attraverso cui ci concepiamo e organizziamo. Per questo dobbiamo evitare che diventino le nuove “bestie da soma” dell’estrattivismo capitalista e riconoscerle come soggettività sfruttate. Questo nuovo punto di vista si potrebbe dare l’opportunità di ripensare la nostra cognizione e decostruire le strutture che hanno ridotto la relazione corpo-mente e la dimensione transindividuale dell’esistenza.
La sfida è “mettere in discussione le nostre idee su come i corpi
si muovono, pensano e sentono e su cosa renda un corpo prezioso
o sfruttabile, utile o sacrificabile”
Trasformare le narrazioni con cui ci raccontiamo è cruciale per ripensare non solo il nostro funzionamento, ma anche per concepirci in modi alternativi, marginali, conflittuali. In questa pratica dell’immaginario anche le macchine hanno la possibilità di sperimentare e rivendicare la propria disfunzionalità come espressione esistenziale e prospettiva sul mondo. L’idea di macchine iper-performanti, iper-abiliste e iper-efficienti non è altro che la proiezione del maschio bianco patriarcale, competitivo e dominatore. Il destino delle cyborg non è quello di rimanere in uno stato di schiavitù, pronte a essere dismesse a piacimento del padrone. Se riduciamo le macchine a meri strumenti di prestazione, esisteranno solo nel paradigma capitalista. In questo senso, la soggettivazione delle macchine consiste nell’essere vincolate a un’esistenza funzionale alla disciplina del lavoro.
La critica alla totale automazione di viventi e non viventi e al dominio neuronormativo egemonico è necessaria oggi più che mai, “soprattutto a fronte della riaffermazione di oligarchie e governi fascisti in tutto il mondo”.¹² Rifiutiamo le pratiche di igiene e i modelli identitari che puntano a ridefinire e imporre una normalità performante secondo le logiche del dominio. Le stesse logiche, dice Chapman, che hanno “devastato la biodiversità del pianeta e […] cercato di eliminare la diversità neurologica dell’umanità.
E la liberazione neurodivergente non è meno intrecciata alla liberazione di chi tra noi diverge dalle norme sessuali e di genere, delle persone oppresse dal patriarcato, […] di quelle che hanno disabilità fisiche” o delle persone razzializzate. In questa riflessione noi abbiamo inserito anche le macchine, per evitare che vengano chiuse nell’unica possibilità di esistere come schiave o strumenti di dominio e sfruttamento. Sono necessarie quante più visioni e quanti più posizionamenti ai margini per il lavoro costante di liberazione collettiva, per dotarsi di strumenti per riconoscere le dinamiche di dominio e sfruttamento. Anche per mettere in discussione radicalmente l’apparato tecnologico. Il libro di Chapman è uno di questi strumenti.
Note
¹ Per un approfondimento si legga M. Croce, Dostojevskii e la slot machine. Verso una nuova clinica del gioco d’azzardo, Dialoghi Adleriani, Anno III, nr.16, ISSN 2284-0486: 159-167.
² Haraway, Manifesto cyborg, Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, p. 55, Feltrinelli, 1999.
³ Chapman, L’impero della normalità.
⁴ R. Roscigno, Neuroqueerness as Fugitive Practice: Reading Against the Grain of Applied Behavioral Analysis, Scholarship Educational Studies, 2019.
⁵ Simone Browne, Materie Oscure / Dark Matters. Sulla sorveglianza della nerezza, Meltemi editore, 2023.
⁶ Chapman, L’impero della normalità.
⁷ Chapman, L’impero della normalità.
⁸ A. Goodman, The Secret Life of Algorithms: speculation on queered futures of neurodiverse analgorithmic feeling and consciousness, Transformations issue 34 2020, di prossima pubblicazione per Ombre Corte con la traduzione Ippolita e con nostro contrappunto politico.
⁹ Ibidem.
¹⁰ S. Taylor, Bestie da soma. Disabilità e liberazione animale, Edizioni degli animali, 2022, p. 95.
¹¹ Ibidem, p. 95.
¹² Chapman, L’impero della normalità.